Racconto letto ad alta voce da Clelia Tollot
“Quando Bàal-shem doveva assolvere un qualche compito difficile qualcosa di segreto per il bene delle creature, andava allora in un posto nei boschi, accendeva un fuoco e diceva preghiere, assorto nella meditazione, e tutto si realizzava secondo il suo proposito. Quando una generazione dopo il Maggìd di Meseritz si ritrovava di fronte allo stesso compito, andava nello stesso posto nel bosco e diceva non possiamo più accendere il fuoco, ma possiamo dire le preghiere, e tutto andava secondo il suo desiderio. Ancora una generazione dopo, Rabbì Moshè Leib di Sassow doveva assolvere lo stesso compito.
Anche egli andava nel bosco e diceva non possiamo più accendere il fuoco e non conosciamo più le segrete meditazioni che vivificano la preghiera, ma conosciamo il posto nel bosco dove tutto ciò accadeva, e questo ci deve bastare. E infatti ciò era sufficiente. Ma quando di nuovo, un’altra generazione dopo, Rabbì Yisra’èl di Rischin doveva anch’egli affrontare lo stesso compito, se ne stava seduto nella sua sedia e diceva non possiamo più accendere il fuoco, non possiamo più dire le preghiere, e non conosciamo più il luogo nel bosco, ma di tutto questo possiamo raccontare la storia[1].
E il suo racconto, da solo, aveva la stessa efficacia delle azioni degli altri tre.”
La narrazione nella vita quotidiana
 La narrazione, mi è stato chiesto di parlare di questo, è un tema immenso. E poi tocca qualcosa di sacro e qualcosa di magico sicuramente, il racconto che abbiamo sentito lo diceva. Dirò solo qualcosa di generale sulla narrazione, poi mi concentrerò su quello che credo interessi oggi, cioè certi tipi di narrazioni di sé, che riguardano la propria stessa esperienza.
La narrazione, mi è stato chiesto di parlare di questo, è un tema immenso. E poi tocca qualcosa di sacro e qualcosa di magico sicuramente, il racconto che abbiamo sentito lo diceva. Dirò solo qualcosa di generale sulla narrazione, poi mi concentrerò su quello che credo interessi oggi, cioè certi tipi di narrazioni di sé, che riguardano la propria stessa esperienza.
Il titolo parla della narrazione nella vita quotidiana… Ricordiamoci che non è vero che non si racconti, e voi lo sapete benissimo. Nel lavoro, ma anche nella vita quotidiana fuori dal lavoro, noi ci scambiamo un sacco di storie.
Naturalmente siamo pieni di agenzie narrative che raccontano per noi e a noi. Accendiamo la televisione, andiamo al cinema, eccetera, ma anche raccontiamo a viva voce: “E poi ieri come è andata? Oh sai, poi dopo l’ho incontrato Giovanni, lui mi ha detto “, eccetera.
Sì, raccontiamo, naturalmente anche sul lavoro. Lo facciamo comunque, ma forse potremmo farlo anche di più e soprattutto badando a che tipo di racconti ci facciamo. Comunque se penso al quotidiano, al caso più banale, io che racconto una storia a te, breve, un frammento, però ti racconto qualcosa.

Ecco, è la forma elementare della narrazione, face to face, che vuol dire anche body to body, perché c’è anche la comunicazione non verbale ovviamente. Bene, e allora ecco che qui io sto raccontandoti qualcosa e il mio narrare improvvisamente fa una cosa normalissima eppure straordinaria. Apre un mondo.
Contemporaneamente io e te che mi ascolti siamo qui, due poltrone, una panchina, quel che sia, e siamo in un altro posto che si apre grazie al racconto. Si apre un mondo narrato, non è il mondo empirico in cui siamo seduti, è un mondo che si apre all’immaginazione, è magia. La stessa che avviene anche al cinema, alla televisione, ma la sua cellula elementare è la narrazione come la facciamo normalmente.
Potreste dire, sì va bene, ma racconti cose vere oppure cose inventate? È una differenza importante? No, nelle prime definizioni necessarie a questo discorso non è importante. Scendendo a valle nell’analisi empirica dei racconti la differenza conta e se ci soffermassimo scopriremo che è molto più complicata da definire di quanto non ci piacerebbe.
Vi faccio un esempio, poi se vorrete con le domande ne parliamo. Pensate a un racconto come questo: “io ho ucciso un uomo”. Questo testo, pensatelo se detto in tribunale oppure a teatro. Il testo è lo stesso, il testo non mi ha detto se è fiction o se è testimonianza, è il contesto che me lo dice.
Questo per capire che non è banale distinguere ciò che è fantastico e ciò che è testimonianza. Detto questo sottolineiamo che la narrazione è uno strumento di transito. Io e te durante la narrazione transitiamo in un mondo narrato, un altro mondo, però poi c’è un altro transito.
La storia che il racconto espone transita fra me e te, viene messa in comune. Narrare è una pratica in cui noi mettiamo in comune delle storie, cioè dei mondi narrati. Naturalmente ci sono dei seri motivi per cui non è proprio mai uguale per me e per te il mondo narrato dove entriamo, però c’è molto, molto molto in comune.

La mia Odissea non è proprio la stessa che hai in mente tu, sì però ci capiamo bene se parliamo delle sirene e compagnia. Mondi in comune, oh caspita, in questo mondo individualista, tutti monadi, tutti oggetti diversi, soggetti separati? No. Noi abitiamo mondi in comune, quelli delle storie sicuramente, anche altri aspetti della vita in comune ci sono che ora non ci toccano.
Bene, quindi narrare è una magia, e narrare è un dispositivo transizionale, in due sensi come ho detto. Transizionale fra me e te: in effetti la narrazione è necessariamente un’interazione. Perché se non c’è nessuno a cui narrare io non narro, almeno devo trovare dentro di me un destinatario ideale, un altro io, un io futuro, il mio angelo custode.
Ci vuole un destinatario, in concreto, e se sto all’esempio elementare della narrazione faccia a faccia, il destinatario è tutto fuorché passivo. Intanto ci vuole, perché se no non narro, però se lo faccio a voce davanti a lui o lei fa un sacco di cose. Probabilmente tutto è cominciato perché lui o lei mi ha chiesto qualcosa, “…e come è andata ieri?”. Grazie, sei tu che hai fatto partire il racconto destinatario, grazie.
E poi puoi interrompermi, e poi puoi fare le espressioni, delle facce, le facce magari con dei suoni. Ma questo non fa parte del racconto? Sì, invece, ne fa propriamente parte. Addirittura possono essere dei feedback che mi servono per dirigere meglio il racconto. Con gli studenti lo sapete bene, raccontate qualcosa, badate alle facce che fanno. Li ho presi o no? Sono annoiati? E beh, cambio qualcosa. Sono presi? Bene, proseguo. Il destinatario fa, fa anche se sta zitto, perché già solo l’ascolto è un’enorme partecipazione al racconto.

Per i racconti di cui parlerò tra un attimo, quelli che riguardano sé, io penso che la postura ideale del destinatario sia un ascolto silenzioso, attento. Si vedrà il motivo, perché non avviene sempre e neanche sempre deve avvenire, ma in certi casi sì.
Bene, parliamo dei racconti di sé. Sono quelli in cui c’è una sovrapposizione di io, no? Io, che sono qui che parlo, sono anche l’io del testo. “Io sono stato a pescare”: nel mondo narrato ci sono io che va a pescare, nel mondo empirico ci sono io che racconto questa cosa. Sono interessanti per tantissimi motivi. A me interessa dire che ci sono dei tipi diversi di racconti di sé. Non è che raccontare di sé per forza sia una cosa che deve destare meraviglia, può essere tante cose, perché noi possiamo raccontare di noi stessi per una quantità enorme di motivi, che hanno a che fare con la quantità di differenti occasioni in cui ci troviamo. Tutta questa veramente infinita varietà di racconti di sé, io la immagino come disposta su una riga continua, dove a un polo c’è il mero, semplice, secco, presentarsi. All’altro estremo c’è il cercarsi.
Cerco di spiegarmi. La presentazione di sé è una cosa normalissima e normalmente necessaria. Poco fa io e Clelia siamo stati al bar, non ci conosciamo quasi per nulla e ci siamo detti qualcosa. Il marito fa questo, la moglie quest’altro, abito in questa città. Normale. Fossimo stati a un party, qualcosa di magari un po’ diverso, non ci saremmo detti qualcosa sulle professioni o altro. Normale. Ci si può sottrarre, però è costoso. Cioè quando fai delle cose non normali, lo sapete, si paga. Si può fare, ma si paga. L’avete in mente il giovane Holden, quando lui è sulla metropolitana e c’è la mamma di un suo compagno di scuola? Che gli dice allora chi sei, come stai, cosa fai? E lui gli racconta delle storie pazzesche. Che la madre ha il cancro, che lui stesso non so che ha, eccetera. L’altra resta allibita. Lui si voleva sottrarre, infatti. Si è sottratto a quella cosa normale che è la presentazione di sé. Di solito non facciamo così.
Però cosa facciamo? Scegliamo accuratamente cosa dire. Qui mi sono segnato qualche verso di una poesia di Wislawa Szymborska che si chiama “Scrivere il curriculum”. La conoscete? Qualche verso:
A prescindere da quanto si è vissuto
il curriculum dovrebbe essere breve.
E’ d’obbligo concisione e selezione dei fatti.
Cambiare paesaggi in indirizzi
e ricordi incerti in date fisse.
Di tutti gli amori basta quello coniugale,
e dei bambini solo quelli nati […].
Scrivi come se non parlassi mai con te stesso [2].
Pochi versi. Certe presentazioni di sé sono fatte così.
Dei curriculum ne scriviamo, no? E davvero, lo sappiamo, sbaglieremmo se non facessimo così. Perché? Perché noi sappiamo che le presentazioni di sé sono necessarie, e sono anche diverse a seconda del contesto, dell’occasione, della relazione in cui ci troviamo. In fondo il curriculum cos’è? È una presentazione di sé pubblicitaria. Assumetemi, sono proprio quello che va bene per voi. Datemi la borsa di studio, sono proprio quello che la merita. E questo è il curriculum. E se fosse diverso non funzionerebbe.

Ovviamente in altri contesti ci sono presentazioni diverse a seconda del contesto, della relazione entro cui siamo e dei motivi. Sapete, si può raccontare di sé: fatevi un elenco dei motivi per cui vi è capitato di raccontare di voi stessi. Per chiedere consiglio, mi è successo un guaio, vediamo un po’ se mi aiutate. Per condividere un dolore, eh sì, proprio già la condivisione di un dolore fa bene. O per sedurre. Chi di voi non ha mai raccontato per sedurre? Cioè per apparire interessante, per portare con sé. Io credo di farlo tuttora, da ragazzo sicuramente, ma penso che de te fabula narratur, cioè di ciascuno, tutti lo facciamo. Per sedurre, per mascherarsi, eh sì, eccetera. Per collaborare meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Tanti motivi.

Ciascun motivo ha il suo destinatario, o almeno il suo tipo di destinatario. E poi però andiamo all’estremo opposto. Ci sono dei racconti in cui il problema non è presentarsi, e anche qui però ci vuole il destinatario giusto. Perché ci sono i racconti di sé in cui non lo so già che cosa vorrei dire. In un curriculum tu fai come se sapessi tutto di te stesso. Non è mai vero, ma intanto ti metti in gioco. Ecco, ci sono dei racconti in cui metti in gioco il fatto che delle cose di te non le sai. Mi sembra che non so perché l’ho fatto. Ma veramente lei cosa voleva? Che cosa ho vissuto quando ho vissuto questa cosa? Sono domande che capite, no?
Ecco, qui potremmo dire che in quel caso il racconto è una sorta di messa in ricerca, di ricerca. Ricerca se non del sé (che poi veramente occorrerebbe una lezione apposta per dire cosa diavolo vuol dire sé), ma della propria esperienza. Della propria esperienza. Potreste dire, beh, ma l’esperienza è esattamente quello che conosci, no? Sì, ma come lo conosci?
Walter Benjamin, un autore che io amo molto, che tanti amano, diceva a un certo punto, era un saggio su Proust, sentite che frase tira fuori. “Noi tutti non abbiamo il tempo di vivere i veri drammi dell’esistenza che ci è destinata. Per questo invecchiamo. Non per altro. Le rughe e le grinze sul nostro volto sono i biglietti da visita delle passioni, dei vizi, delle conoscenze che passarono in noi, ma noi, i padroni di casa, non c’eravamo”.
Allora, le rughe e le grinze mi sa che vengono anche da altro. Però questa idea delle conoscenze che passarono in noi mentre noi, i padroni di casa, non c’eravamo, io la sento mia. Anzi, la sento universale. Perché con diversi filosofi potrei dire che l’esperienza è sempre opaca. Opaca a noi stessi. Cioè, sono stato qui. Sono stato qui? Punto di domanda. Dove sono stato? Che cosa so di quello che ho esperito? Sicuramente non tutto. Ma non è che forse ne so troppo poco? Quanto ho omesso perché non riuscivo a sopportarlo? Perché la mia attenzione non era abbastanza? Perché mi metteva in difficoltà? E quanto, perché comunque l’esperienza è più grande dell’io? È più grande.
Io credo che la condizione degli uomini e donne moderni e contemporanei sia caratterizzata da tante cose. Una, importante, è la fretta. Ci manca tempo. Siamo tutti qui adulti e in professioni, e lo sappiamo. Veramente anche i bambini sono pieni di fretta oggi perché gli si dà un sacco di cose da fare. C’è anche il nuoto, c’è la danza, eccetera. Fretta. Ma la fretta, per quel che riguarda il nostro argomento, ti dà poco tempo per raccontare la tua esperienza. Per fermarti, darti una pausa, per lasciare che riemerga l’esperienza e possa essere interrogata.
Ora, interrogare l’esperienza può voler dire molte cose, ma certo vuole dire anche raccontarla. E il racconto serve, potremmo dire, serve l’elaborazione dell’esperienza. Questo per tanti motivi. Il primo è che un racconto usa un linguaggio, quindi impari ulteriormente a articolare quel linguaggio. Ma l’articolazione aiuta a prendere atto di ciò di cui stai così parlando. Poi il racconto usa anche la grammatica e la sintassi del linguaggio che stai usando, qualunque esso sia. Ancora: oggettiva, mette quasi fuori di te, quindi vedi meglio ciò che hai esperito. In genere un racconto ha anche una trama, che vuol dire che ti addestra a mettere nessi di spazio e di tempo. Prima, dopo, durante, intanto, lì, là, sopra, eccetera.

Bene, e infine, abbiamo detto all’inizio che narrare lo si fa in almeno due. Il racconto aiuta l’esperienza perché insieme a un altro io la condivido.
Ho bisogno dell’altro per condividerla, ma questo ‘altro’ me la restituisce come più solida. Ah, ecco, è qualcosa che può essere messo in comune! In fondo le ho trovate le parole per dirlo e adesso la so un po’ di più.
Mi fermo qui, grazie per l’attenzione.
[1] da Scholem, Le grandi correnti della mistica ebraica, p.353
[2] W. Szymborska, Scrivere il curriculum, tr. it. in Gente sul ponte, Scheiwiller, Milano, 1996, p. 69.
Per gentile concessione di Paolo Jedlowski pubblichiamo un estratto del secondo capitolo del volume Il racconto come dimora. Heimat e le memorie d’Europa, Torino, Bollati Boronghieri, 2009, capitolo secondo, pp. 24-31.
…
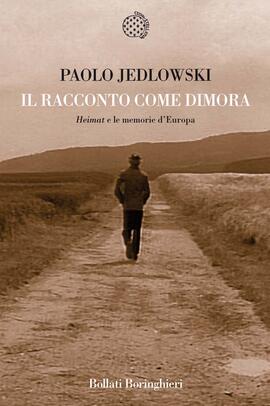 Il racconto è un discorso che apre un mondo all’immaginazione. Il narratore è situato in uno spazio e in un tempo determinati, e lo stesso vale per il suo destinatario: ma entrambi sono anche con l’immaginazione in uno spazio e in un tempo diversi, lo spazio e il tempo di un mondo possibile [1].
Il racconto è un discorso che apre un mondo all’immaginazione. Il narratore è situato in uno spazio e in un tempo determinati, e lo stesso vale per il suo destinatario: ma entrambi sono anche con l’immaginazione in uno spazio e in un tempo diversi, lo spazio e il tempo di un mondo possibile [1].
Ogni storia narrata è un “come se”, è un’ipotesi, una finzione. Può riguardare la vita “vera” oppure un luogo fantastico. Il “mondo possibile” aperto dal racconto può essere inteso infatti come un mondo esistente o esistito nella realtà empirica (come la guerra, per chi ne è tornato), oppure come un mondo possibile soltanto nella fantasia (come una storia di fate). Di solito non si pongono molti problemi a riguardo. Tuttavia, non è sempre una distinzione facile a farsi. Non solo perché realtà e fantasia sono inestricabilmente connesse, ma perchè è una distinzione che dipende più da una sorta di “patto comunicativo” che si instaura a proposito della narrazione, che non da caratteristiche infallibilmente proprie del testo. Per fare un esempio, la confessione di un assassino è un racconto che può realizzarsi esattamente con le stesse parole in un’aula di tribunale o a teatro: a far sì che lo si intenda come un racconto veridico o come una fiction è il contesto in cui il racconto si colloca, e l’accordo implicito fra gli astanti che al contesto è legato [2].
Di fatto, tutto l’universo della narrativa si colloca fra questi due poli: da un lato, vi sono i racconti che tendono a testimoniare la vita, dall’altro, quelli che tendono a moltiplicarla con la fantasia. Anche il cinema, alla cui storia appartiene Heimat, conosce questa doppia possibilità fin dalle sue origini. L’arrivée d’un train a La Ciotat dei fratelli Lumière testimoniava la ferrovia in modo così realistico che gli spettatori temevano di esserne investiti; il Voyage dans la lune di Méliès esplorava una realtà allora possibile solo nella fantasia.
I racconti di cui mi occupo in questo volume hanno a che fare prevalentemente con la narrativa che tende alla testimonianza. Con la narrativa “realistica”, insomma. Vi si tratta di raccontare le cose “come sono andate” o, quando si tratta di fiction (come nel caso di Heimat) di raccontare vicende che assomigliano a quelle che qualcuno ha vissuto. Anche la maggior parte dei racconti che ci scambiamo oralmente si collocano prevalentemente vicino a questo polo della narrativa: naturalmente possono contenere menzogne, e a volte vi si mescolano racconti francamente fantastici, ma nella maggior parte dei casi si tratta di racconti che riguardano cose successe a chi narra, a quelli che conosce, o comunque avvenute nel mondo che si intende “reale”.
Prima di procedere oltre, è opportuno però che precisi i termini che uso. Seguendo i suggerimenti dei narratologi, intendo la storia come l’oggetto di cui si racconta, ovvero il “contenuto” di un certo discorso; il racconto come il discorso mediante cui la storia è evocata; e la narrazione come l’azione mediante cui si racconta[3].
La distinzione è importante perché evidenzia che la narrazione è qualcosa di specifico. Una storia può somigliare o meno alla vita, ma la narrazione, l’atto di raccontare, ne è parte. E un’azione, e, poiché si svolge fra almeno due partecipanti, è propriamente un’inter-azione. La maggior parte delle considerazioni che seguiranno riguardano questo: l’azione di raccontare e le relazioni che vi hanno a che fare [4].
D’altra parte, nella realtà esistono raramente azioni singole, chiaramente isolate da altre: esistono piuttosto concatenazioni di azioni, che, col tempo, tendono inoltre ad assumere forme parzialmente standardizzate: per questi motivi, piuttosto che di azioni, è spesso preferibile parlare di “pratiche”. Vale lo stesso per le narrazioni: più che in singole azioni e interazioni, siamo implicati di norma in pratiche narrative. Queste consistono in quelle pratiche discorsive caratterizzate dal fatto che i discorsi in questione sono racconti. Potrei definirle così: sono quel genere di pratiche in cui, attraverso la circolazione di un racconto, due o più soggetti mettono in comune una storia.
La presenza di questo tipo di pratiche è probabilmente una costante umana. Come ha scritto Ricoeur, “non sappiamo che cosa sarebbe una cultura nella quale non si sappia più che cosa significhi raccontare” [5]. Tuttavia, si trasforma. La scrittura e più oltre una lunga serie di innovazioni mediali hanno trasformato le pratiche narrative al punto di farne temere, se non la scomparsa, quanto meno una certa atrofia. È come abbiamo visto, la tesi di Benjamin.
Vi sono diverse ragioni a favore di questa tesi, almeno per quanto riguarda le pratiche narrative che si dispiegano oralmente fra persone compresenti nello spazio e nel tempo. La più ovvia sta nel fatto che nel mondo contemporaneo vi sono innumerevoli agenzie che si occupano di rifornirci di storie a vari titoli e per vari motivi. Per ascoltare una storia non abbiamo bisogno di rivolgerci a una persona in carne e ossa. L’interazione di cui la narrazione consiste si scompone: l’azione di raccontare si separa da quella di ascoltare. Ma, così come la comparsa dei vari mezzi di comunicazione che si sono succeduti nel tempo non ha cancellato l’esistenza di conversazioni faccia a faccia, allo stesso modo non è vero che abbiano cancellato definitivamente pratiche narrative di carattere orale.
Rispetto ai racconti che ci forniscono il cinema o la letteratura, queste pratiche possono apparire narrazioni minori. Ma sono importanti. Certo, nelle conversazioni non è sempre facile distinguere il discorso narrativo dagli altri generi di discorso, e dunque la narrazione vera e propria dalla più ampia pratica del conversare. Il discorso narrativo è un discorso che rappresenta il tempo e la contingenza: la condizione minimale perché un’enunciazione possa essere qualificata come narrativa è che qualcuno dica ad un altro che “è successo qualcosa” [6]. Tuttavia, quasi ogni espressione verbale è legata a una dose più o meno piccola di narrazione, che può esprimersi nel resoconto frammentario di qualche avvenimento o nell’aneddoto appena accennato oppure nei discorsi più definiti che riconosciamo come veri e propri racconti [7].
Questi ultimi sono molto più frequenti di quanto non si pensi. Il tempo per dispiegare un racconto come si deve è forse oggi più raro di quanto non fosse una volta. Ma sono racconti anche quelli che scambiamo con conoscenti che non vedevamo da tempo (“e poi, com’è andata?”; “E di lei, che mi dici?”), con i figli a cui domandiamo come è andata la scuola, con i colleghi con i quali vantiamo un affare, con gli amici, in riunioni con i parenti… Ogni cerchia sociale ha i suoi racconti. Ciò avviene, se non altro, perché raccontare “cosa è successo” è uno strumento essenziale per coordinare le azioni, per informarci sull’ambiente in cui stiamo. Ma anche perché raccontare significa consolidare le relazioni. A volte, come in una cerchia di amici, ci si raccontano sempre le medesime cose: ma il punto non è scambiarsi informazioni, bensì scambiarsi per l’appunto il racconto, ribadire narrando che si hanno certe storie in comune, e così ribadire i propri legami.
All’interno della conversazione, la narrazione si costituisce come una lunga sequenza, durante la quale uno degli interlocutori prende possesso della parola e l’altro assume prevalentemente la parte dell’ascoltatore. Il primo appare il protagonista dell’azione comunicativa, ma il secondo è tutt’altro che passivo. In generale, sappiamo che ciascuna enunciazione presuppone, per la sua realizzazione, l’esistenza non soltanto di un parlante ma anche di un ascoltatore. Ogni enunciazione linguistica è sempre orientata verso un altro, anche quando quest’ultimo non esista attualmente come persona reale [8]. Ma nelle conversazioni e nelle narrazioni faccia a faccia ciò è particolarmente evidente, e l’agire del destinatario è palese. Con le sue aspettative determina in parte ciò che viene detto. Contribuisce – implicitamente o meno – alla definizione della situazione in corso (ad esempio intendendo che “stiamo scambiandoci informazioni su conoscenti comuni”, che “stiamo facendo passare del tempo”, o che “si tratta di una confessione”). E di rado è completamente muto. Espressioni del viso, posture, interiezioni, domande, commenti: in tutto ciò si esprime la sua collaborazione al racconto. La sua attenzione o la sua disattenzione, la sua partecipazione emotiva o il suo disinteresse retroagiscono sul narratore e sul contenuto della narrazione.
La narrazione orale si dispiega dunque come un’interazione. È la pratica grazie a cui un narratore e un destinatario mettono in comune una storia: ma quali storie, come e perché vengano messe in comune dipende dalla relazione che sussiste fra il narratore e il destinatario, la quale a sua volta può essere rafforzata o, in certi casi, modificata dalle storie che ospita.
Non a tutti infatti si raccontano le medesime cose [9]. È una constatazione facile a farsi se si osservano le narrazioni dal punto di vista sociologico, e soprattutto le narrazioni orali. Forse è meno evidente a chi si concentri sui testi. Per quanto la narrazione mediata dalla scrittura o da una pellicola cinematografica implichi comunque la presenza di un destinatario (almeno in quanto destinatario ideale, o “destinatario modello” [10]), la mediazione offerta dal testo comporta infatti di norma la separazione del narratore dal suo pubblico empirico, e così ne emancipa la prestazione dai vincoli che raccontare in faccia a un altro comporterebbe.
È per questo che uno scrittore come Forster, ad esempio, sosteneva la relativa superiorità del romanzo rispetto a ciò che si può narrare all’interno di una conversazione. Proprio a causa della separazione tra il narratore e il destinatario, il romanzo permette infatti di toccare argomenti che in una situazione faccia a faccia potrebbero venire affrontati solo eccezionalmente, con cautela, o non venire affrontati per nulla: l’anonimità della relazione permette di aggirare il riserbo e il pudore di cui le relazioni personali devono tener conto molto più attentamente [11].
Ma, quanto alle narrazioni che punteggiano le nostre conversazioni, la qualità della relazione determina quella della narrazione e dei racconti che circolano; e la qualità di questi ultimi determina a sua volta di che tipo di relazione si tratti.
Contenuti, forme e funzioni della narrazione, nella vita quotidiana, possono di conseguenza essere tanto vari quanto sono varie le relazioni in cui ci troviamo implicati.
Immaginiamo, ad esempio, di trovarci in un bar. Qui si racconta fra sconosciuti, o al massimo fra conoscenti. I contenuti riguardano qualcosa che si è visto in TV o si è letto sul giornale. Spesso i racconti sono del tipo “Conosco uno che…” o “Hai sentito di quello…” [12]. Questi racconti rispondono al semplice desiderio di stabilire un contatto, senza mettersi in gioco più del necessario. La funzione della narrazione è così vicina alla mera dimensione “fàtica” della comunicazione: il fatto che, comunicando, si stabilisce un rapporto fra gli interlocutori[13]. D’altro canto, può assumere anche valenze ludiche: la narrazione come intrattenimento reciproco, arte di una socievolezza fine a se stessa.
Questi sono i casi in cui i contenuti del racconto rivestono l’importanza minore. Un po’ come quando i bambini chiedono un racconto prima di andare a dormire: dopo tutto, il bambino che vuole sentirsi raccontare una storia vuole innanzitutto sentirsela raccontare. Il contenuto del racconto è, almeno in parte, solo il pretesto per dar luogo a una relazione[14]. Essere immersi in una relazione narrativa è infatti anche l’espressione di un desiderio che ha la narrazione medesima – la presenza dell’altro, l’attenzione che esprime – per proprio oggetto. Il contatto che si stabilisce narrando può servire scopi diversi, ma è anche uno scopo in se stesso. È come dire “io ci sono, e tu anche”, un riconoscimento di esistenza reciproco.
Spostiamoci ora in un paese, o in una cerchia dove “si conoscono tutti”: qui i racconti possono assumere la forma del pettegolezzo. Il pettegolezzo è una delle forme più diffuse della narrazione quotidiana. I contenuti qui hanno a che fare con la curiosità per il prossimo, ma sono in gioco anche etichette, stigmi, valutazioni e confronti. Le funzioni prevalenti sono quelle della costituzione di una memoria del gruppo e quella dell’affermazione delle sue norme morali, ma, sopra a tutte, è evidente quella di un vero e proprio controllo sociale. (Non senza che siano presenti, per gli individui, altri ventagli di scopi consapevoli o meno: quello di dar sfogo nell’immaginazione a certi desideri repressi, ad esempio, o quello di manipolare fatti o reputazioni).
Entriamo ora in un ufficio o una fabbrica. Alcuni racconti servono a comunicare parte di ciò che è necessario a coordinare le azioni o ad assumere le decisioni appropriate; alcuni sono ciò attraverso cui i lavoratori pubblicizzano, per così dire, le proprie abilità; se vi sono nuovi assunti, sono anche parte integrante del loro tirocinio, aneddoti nei quali si condensano l’esperienza e le regole del mestiere. Ciò era particolarmente vero nell’artigianato, ma anche le complesse organizzazioni del lavoro di oggi comprendono spazi in cui i lavoratori più vecchi raccontano storie ai nuovi arrivati, narrazioni aziendali in cui ci si dispensa consigli su come comportarsi, ci si introduce alle dimensioni informali delle relazioni, si costruisce la “morale” del gruppo e si definiscono le identità degli attori coinvolti e dell’organizzazione stessa [15].
L’elenco di esempi potrebbe continuare pressoché all’infinito [16]. Se li ho richiamati è per confermare che la narrazione è tutt’altro che assente dalla vita quotidiana moderna. Attraverso questo tipo di pratiche costruiamo insieme la definizione della realtà in cui abitiamo. Ma non si raccontano a tutti le medesime cose. È la relazione che sussiste fra gli interlocutori a determinare cosa si racconta e cosa non si può raccontare. Forme e contenuti della narrazione ne dipendono. Così come ne dipendono le funzioni che la narrazione viene ad assolvere.
Queste sono molteplici, e spesso si intrecciano le une con le altre. Nei primi esempi che ho riportato è in primo piano la funzione dell’intrattenimento reciproco. Nei pettegolezzi, a loro volta, si tratta di mettersi reciprocamente al corrente di certe informazioni, ma anche di favorire l’integrazione del gruppo e di controllare l’adeguamento dei membri alla sua morale. Nelle narrazioni sul lavoro si tratta in primo luogo di condividere saperi più specializzati, di trasmettere regole e conoscenze pratiche.
In tutti i casi, la funzione che la narrazione assolve ha però anche a che fare con il rafforzamento dei legami sociali. Può trattarsi di legami diversi. Ad essere in gioco può essere lo stabilirsi di un contatto effimero, come quello di coloro che si trovano assieme in un bar, oppure il rafforzamento o addirittura la creazione di relazioni stabili nel tempo.
Si potrebbe parlare in proposito di una vera e propria funzione comunitaria della narrazione: la funzione più propriamente connessa alla sua dimensione relazionale. I funzionalisti la chiamerebbero una “funzione latente”: nel senso che non è necessariamente manifesta agli occhi degli attori implicati. Ma è una sorta di “macrofunzione”: si realizza in ogni caso, accompagnandosi ad altre funzioni specifiche. Se narrare è raccontare qualcosa a qualcuno, questa funzione corrisponde a ciò che di più elementare la narrazione produce: il riconoscimento reciproco degli interlocutori in quanto narratori e destinatari, e il senso di avere, grazie al racconto che circola, qualcosa in comune. Insomma, narrare crea a suo modo “comunità”.
È questo tipo di comunità che Paul Simon, reduce dalla guerra, rifiuta. Conosce tutte le pratiche narrative di cui abbiamo parlato, ne fa uso: ma non a proposito di ciò che ha vissuto.
***



