Dal 17 al 19 ottobre 2024 si è tenuta a Roma la IX edizione dell’annuale seminario in cui Invalsi presenta ricerche sui dati relativi alle sue prove nazionali ed a quelle internazionali, accanto a tavole rotonde che radunano esponenti importanti di centri di ricerca a livello nazionale ed internazionale.
Il Seminario, promosso insieme ad Invalsi anche da Istat, Espanet e Banca d’Italia, ha visto, come nelle altre edizioni, la presentazione di contributi di ricercatori di università e di centri di ricerca nazionali ed internazionali. Un appuntamento annuale di respiro nazionale ed internazionale per l’Italia, che presenta ricerche e confronti sul tema della scuola, basati sui dati.
Ricerca e dati (più) a servizio della scuola e delle politiche scolastiche
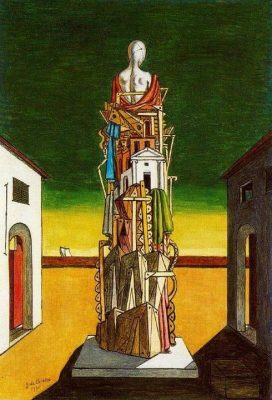 Il focus sui dati per assumere riflessioni e decisioni politiche è un problema in tutti i paesi, come tutti gli anni in questa occasione ci ripetono i ricercatori che vengono da tutte le parti del mondo, a causa dei condizionamenti che la politica subisce necessariamente, poiché si basa sul consenso. Ma nel nostro paese si tratta di un problema anche più grave, a causa del nostro storico background culturale, che guarda con diffidenza alla realtà che i dati necessariamente rappresentano, preferendovi spesso una dimensione utopistica e parenetica. Anche più spesso i dati vengono usati per giustificare decisioni assunte sulla base di altri fattori. Ma nel corso dei lavori sono emersi anche spunti di autocritica da parte del mondo della ricerca, in particolare nelle riflessioni di Roberto Ricci, presidente Invalsi. Che da tempo ed in più contesti va auspicando che la ricerca esca dalla autoreferenzialità e finalizzi i suoi oggetti ed il suo linguaggio alla realizzazione concreta degli obiettivi positivi che indica e che sono in ultima analisi le ragioni della sua esistenza. Che non abbia insomma timore di “sporcarsi le mani”.
Il focus sui dati per assumere riflessioni e decisioni politiche è un problema in tutti i paesi, come tutti gli anni in questa occasione ci ripetono i ricercatori che vengono da tutte le parti del mondo, a causa dei condizionamenti che la politica subisce necessariamente, poiché si basa sul consenso. Ma nel nostro paese si tratta di un problema anche più grave, a causa del nostro storico background culturale, che guarda con diffidenza alla realtà che i dati necessariamente rappresentano, preferendovi spesso una dimensione utopistica e parenetica. Anche più spesso i dati vengono usati per giustificare decisioni assunte sulla base di altri fattori. Ma nel corso dei lavori sono emersi anche spunti di autocritica da parte del mondo della ricerca, in particolare nelle riflessioni di Roberto Ricci, presidente Invalsi. Che da tempo ed in più contesti va auspicando che la ricerca esca dalla autoreferenzialità e finalizzi i suoi oggetti ed il suo linguaggio alla realizzazione concreta degli obiettivi positivi che indica e che sono in ultima analisi le ragioni della sua esistenza. Che non abbia insomma timore di “sporcarsi le mani”.
In effetti in apertura una tavola rotonda ha visto confrontarsi esperti di diversi Paesi su come usare i dati delle valutazioni standardizzate a livello internazionale. Una sfida particolarmente attuale in questo periodo in Italia, in relazione alla necessità di un fruttuoso utilizzo dei fondi PNRR. Aline Pennisi (Unità di Missione New Generation UE-MEF), in quanto responsabile dei fondi per la scuola, ha sostenuto che una scelta importante sia quella di lavorare con gli insegnanti sui dati individuali, per creare “un buon rapporto fra ricerca e politica e per rendere gli investimenti fruttuosi”… I focus della ricerca devono essere anche per lei i più rilevanti per la politica e non per l’accademia ed accompagnare le riforme su argomenti come i meccanismi di incentivazione dei docenti, la mobilità o assicurare strategie di valutazione che includano la possibilità di ripetizione in altri contesti….Per questo è necessaria alla fine –dopo due decenni!- una adeguata formazione delle scuole per la lettura dei risultati INVALSI che non va data assolutamente per scontata e che non può essere lasciata alla improvvisazione ed alla buona volontà, con la scusa, se è consentito aggiungere, dell’autonomia. Oltre ad una gestione centralizzata e valutata delle attività di innovazione e recupero previste, con incentivi e modalità di verifica. In questo quadro si colloca la presentazione della nuova piattaforma di restituzione dei dati INVALSI alle scuole che è finalizzata a far raggiungere più agevolmente a tutte questi obiettivi.
A riprova della centralità crescente del rapporto con le scuole, una sessione è stata dedicata a un bilancio delle ultime fasi del Sistema nazionale di valutazione (SNV). Il cui futuro da tempo sembra quanto meno incerto, nonostante la efficace estensione in corso ad altre parti del sistema formativo, quali i centri di formazione professionali e soprattutto le scuole dell’infanzia, cui è stata dedicata anche una presentazione. La latitanza in proposito dei decisori politici- non diversa peraltro da quella di altri predecessori- ha generato conseguentemente problemi di finanziamento ed organizzativi, fra cui in particolare la cronica mancanza di ispettori, componenti obbligate dei Nuclei esterni di valutazione. Causa o effetto di ciò la scarsa incisività sulla opinione pubblica, che non vi riconosce ancora uno strumento di valutazione e di orientamento a proposito delle scuole dei figli. “Scuola in chiaro” (che peraltro non prevede l’obbligo per le scuole di esporre i dati dei risultati Invalsi) sembra molto meno conosciuta di Eduscopio della Fondazione Agnelli, che orienta soprattutto nella scelta delle scuole superiori.
Rischi e benefici dell’Intelligenza Artificiale

Di stretta attualità la plenaria dedicata alla Intelligenza Artificiale, in particolare alle legislazioni di controllo in via di definizione nei diversi Paesi, a partire da quella europea. Una ottica tipica di un periodo precedente a quello attuale, nel quale invece al nostro continente viene attribuita la responsabilità di aver troppo tirato il freno e poco investito e promosso, trovandosi conseguentemente oggi in una posizione di difficoltà. Coerentemente con questa impostazione ha particolarmente colpito un video sulle sue applicazioni in corso di sperimentazione in Cina: bambini dotati di una fascia elettronica in fronte che segnala la loro maggiore o minore concentrazione sul compito, con successiva creazione di un grafico a disposizione dell’insegnante. Nel dibattito successivo si sono viste posizioni diversificate: c’è chi teme che l’uso di strumenti così potenti condizioni ed amplifichi, fra l’altro, modi di pensare stereotipati in senso negativo (come quelli sulle donne). E chi invece ritiene da un lato che lo sviluppo (positivo) della tecnica sia inarrestabile perché porta benefici oggettivi e dall’altro che, per l’uomo, liberarsi dell’aspetto ripetitivo del suo lavoro consenta una maggiore focalizzazione sulle attività più creative.
Dati che continuano a scavare nel tema dell’equità
 La questione dell’equità è stato il tormentone della sociologia sulla scuola negli ultimi decenni. Figlia della convinzione che la scuola possa fare molto, se non tutto, per garantirla. Ed in molti aspetti forse rischiando di confondere equità con eguaglianza. Francois Dubet ricorda che lo sviluppo della scolarità nell’Occidente del dopoguerra ha avuto due forti motivazioni per certi versi non sovrapponibili: lo sviluppo economico e la coesione sociale, possibile attraverso la redistribuzione, in questo caso del sapere, premessa indispensabile della democrazia. Ma lo stesso Dubet oggi di fronte ai risultati non esaltanti fin qui ottenuti si domanda se la scuola possa davvero ricoprire un tale ruolo salvifico e non piuttosto la società a cercare di essere meno diseguale, permettendo così alla scuola “di fare serenamente il suo mestiere”. Le ricerche presentate ai seminari Invalsi scavano da sempre su questo tema in misura cospicua.
La questione dell’equità è stato il tormentone della sociologia sulla scuola negli ultimi decenni. Figlia della convinzione che la scuola possa fare molto, se non tutto, per garantirla. Ed in molti aspetti forse rischiando di confondere equità con eguaglianza. Francois Dubet ricorda che lo sviluppo della scolarità nell’Occidente del dopoguerra ha avuto due forti motivazioni per certi versi non sovrapponibili: lo sviluppo economico e la coesione sociale, possibile attraverso la redistribuzione, in questo caso del sapere, premessa indispensabile della democrazia. Ma lo stesso Dubet oggi di fronte ai risultati non esaltanti fin qui ottenuti si domanda se la scuola possa davvero ricoprire un tale ruolo salvifico e non piuttosto la società a cercare di essere meno diseguale, permettendo così alla scuola “di fare serenamente il suo mestiere”. Le ricerche presentate ai seminari Invalsi scavano da sempre su questo tema in misura cospicua.
Alcune acquisizioni di quest’anno In sintesi:
- sembrerebbe che i bias (distorsioni della valutazione di una situazione educativa – in questo caso l’orientamento – indotte da un pregiudizio del soggetto che valuta) degli insegnanti nell’orientamento verso la scuola secondaria in relazione alla classe sociale degli allievi stessi, siano propri specialmente degli insegnanti maschi verso gli allievi dello stesso genere e degli insegnanti di 45-50 anni.
- quanto alle disparità educative fra nativi ed immigrati in Italia dal periodo prepandemico fino al postpandemico, gli studenti nelle prime classi mostrerebbero una resilienza iniziale per poi crollare nelle classi più alte; il contrario avverrebbe nel periodo postpandemico in cui la scuola elementare diminuirebbe nelle prestazioni cognitive di base analizzate da Invalsi, mentre la scuola media tenderebbe a recuperare nello stesso campo, ma non per gli immigrati di prima generazione. Ma soprattutto la ricerca sostiene che le famiglie degli immigranti spesso nutrono aspirazioni educative più alte dei corrispondenti nativi: una realtà molto interessante anche in relazione alle posture da assumersi nei confronti dell’immigrazione (regolata).
Sul tema dell’equità sarebbe forse utile anche esplorare nuovi campi. Nel corso del seminario si è tenuta la presentazione del libro di Roberto Ricci Le competenze digitali nella scuola. Un ponte fra passato e futuro (Il Mulino, 2024) nel quale si avanza il timore che nell’immediato futuro la disequità si realizzi sempre più sul terreno delle competenze informatiche. Sulle quali pertanto sorge il dubbio che sarebbe magari necessaria una maggiore vigilanza, forse anche attraverso un ampliamento delle valutazioni standardizzate a quel terreno.
Al contrario, sul tema della plusdotazione a quanto pare da più edizioni non è possibile registrare più di una relazione, nonostante che le pagine dei giornali e dei siti specializzati sulla scuola siano sempre più attente al problema ed alle problematiche che genera. Anche a livello della ricerca – che dovrebbe sempre avere una funzione di avanguardia-prosegue la sostanziale marginalità del tema come a livello istituzionale e del comune sentire scolastico.
Differenze di genere: risultati di matematica e carriere STEM
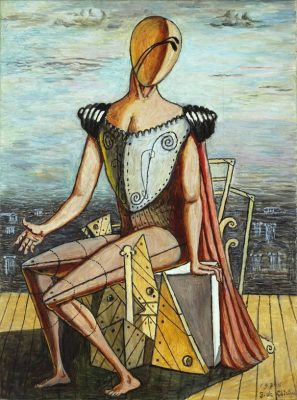 La questione femminile ha sempre avuto un posto importante nei Seminari Invalsi e questo ultimo non ha fatto eccezione. In particolare ci si concentra negli ultimi tempi non tanto sull’accesso e sui risultati scolastici delle ragazze (che presentano dati molto soddisfacenti) quanto sul rapporto con la Matematica e con le carriere STEM. La percentuale di giovani che vi accedono è sempre più assunta come indicatore delle tendenze allo sviluppo economico da parte dei vari paesi. Una rilevazione CSET di Oliss- McFaul si è domandata sulla base dei dati del 2020 quale sia la distribuzione dei laureati STEM a livello globale con risultati per certi versi sorprendenti: Cina 41%, Russia 37%, Germania 36%, Iran 33%, India 30%, Francia 26%, Messico 26%, USA 20%. Significativo anche il rimedio proposto per gli USA: importare laureati dai paesi in via di sviluppo.
La questione femminile ha sempre avuto un posto importante nei Seminari Invalsi e questo ultimo non ha fatto eccezione. In particolare ci si concentra negli ultimi tempi non tanto sull’accesso e sui risultati scolastici delle ragazze (che presentano dati molto soddisfacenti) quanto sul rapporto con la Matematica e con le carriere STEM. La percentuale di giovani che vi accedono è sempre più assunta come indicatore delle tendenze allo sviluppo economico da parte dei vari paesi. Una rilevazione CSET di Oliss- McFaul si è domandata sulla base dei dati del 2020 quale sia la distribuzione dei laureati STEM a livello globale con risultati per certi versi sorprendenti: Cina 41%, Russia 37%, Germania 36%, Iran 33%, India 30%, Francia 26%, Messico 26%, USA 20%. Significativo anche il rimedio proposto per gli USA: importare laureati dai paesi in via di sviluppo.
La presentazione di Martini e Siniscalco ha offerto una convincente sintesi di quanto fin qui rilevato nelle ricerche sulle valutazioni nazionali ed internazionali occupandosi del gap di genere fra gli studenti italiani in matematica in PISA 2022.I ragazzi sono superiori sia per quanto riguarda i processi che i contenuti. Il gap è maggiore ai livelli più alti, in coerenza con le aree geografiche ed i tipi di scuola. Continuano a registrarsi fra le ragazze più alti livelli di ansietà in proposito e minore sicurezza di sé. Tuttavia le ragazze ricevono voti più alti (forse in relazione all’impegno) e ciò avviene soprattutto ai livelli più bassi di status economico-sociale. Nonostante ciò, continuano a scegliere percorsi tradizionalmente femminili sia nelle scuole superiori che all’università anche perché la loro motivazione strumentale verso la Matematica (non causata da interesse originario ma dall’utilità dello specifico apprendimento in vista di sbocchi lavorativi) è più bassa. Ed in questo la presentazione di Bertoletti della Commissione europea ha sottolineato il ruolo della influenza dei ruoli della madre e delle insegnanti: il fatto che le madri non lavorino può avere una influenza significativa in senso negativo sul rapporto delle figlie con la Matematica, ma anche maggiore può essere il ruolo delle insegnanti donne di matematica che si avvicendano nel corso della scolarità e che possono avere un impatto positivo o negativo sulle ragazze.
Proseguendo nel filo del discorso, in chiusura dei lavori la presentazione di Falzetti – la organizzatrice del Seminario – e Giannantoni si è domandata quali siano le differenze di genere nelle carriere universitarie nelle STEM. Con l’obiettivo finale non tanto di avere una situazione di perfetto bilanciamento, quanto di permettere a ciascuna di fare le proprie scelte in modo meno condizionato possibile.
Mette più a fuoco il periodo di lavoro ed i problemi economici il paper dei ricercatori della Banca d’Italia. Le donne guadagnano meno all’inizio della carriera; per le laureate il tipo di azienda scelto – grande o piccolo-medio – spiega quasi il 60% di questo gap anche dopo 5 anni dalla laurea, poiché le scelte diverse sono associate con prospettive di mercato del lavoro molto differenti.
Dati sul divario geografico
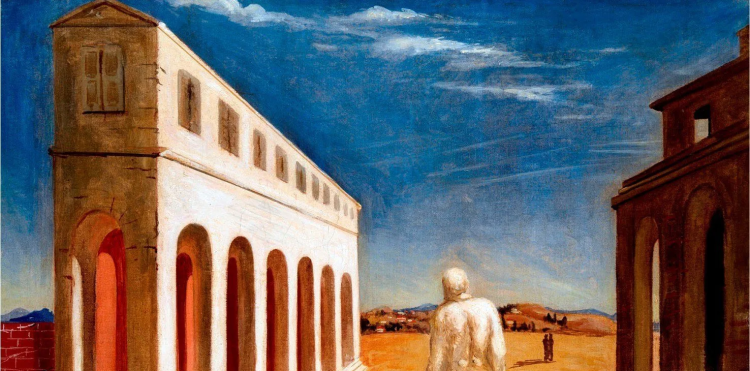
Al solito il Sud è poco presente. Un paper ci conferma che il flusso di studenti dal Sud verso la formazione terziaria del Centro e soprattutto del Nord è alto per studenti di liceo classico, con più alto livello di Matematica e di titoli di studio dei famigliari. Al crescere di queste variabili cresce la propensione allo spostamento, mentre negli atenei del Sud prevalgono le aggregazioni di studenti locali con un più basso livello di Matematica e di titolo di studio dei genitori. Sola eccezione le università campane che trattengono giovani simili dal territorio e drenano anche da altra parte del Sud. Una informazione che conferma l’ipotesi di una forte segregazione sociale in quel sistema scolastico, probabile causa fra l’altro del suo basso livello complessivo. Una segregazione che si manifesta fra le classi durante l’obbligo, fra i tipi di scuola (o licei o drop out in mancanza di una formazione professionale dignitosa) nella secondaria e a livello del terziario addirittura in una emigrazione a scopo formativo. Dal punto di vista delle differenze geografiche, non stupirà venire ad apprendere – per l’ennesima volta – da un’altra ricerca che una significativa eterogeneità nel livello degli apprendimenti è presente fra le province italiane. Queste differenze sono significative in Matematica, che presenta un chiaro gradiente Nord-Sud, mentre in Italiano si registra un gradiente più debole che si palesa soprattutto a partire dalla scuola secondaria. Aspettiamo che si metta mano al tema in modo meno rapsodico.
L’equità va tenuta insieme all’eccellenza
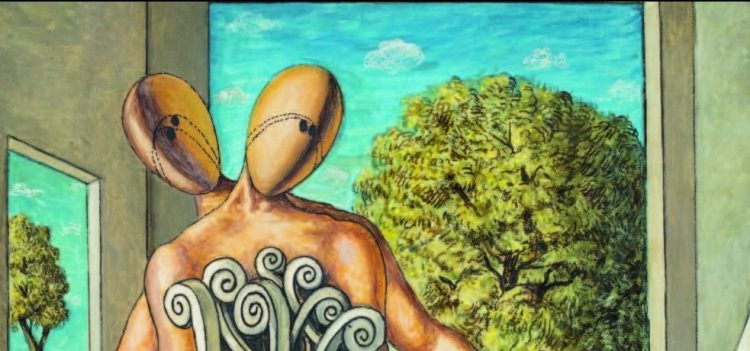
Da ultimo un elemento di grande attualità ha trovato posto nel Seminario. Marco Montanari del Direttorato Generale europeo per Educazione, Gioventù, Sport e Cultura ha presentato il Rapporto UE 2023 The twin challenge of equity and excellence in basic skills in the EU il primo rapporto ufficiale europeo non centrato solo sul tema Equità che utilizza i dati PISA dei Paesi dell’Unione. I risultati dei quindicenni di tutte le nazioni europee (che partecipano a PISA fin dall’inizio) in Lettura, Matematica e Scienze sono stati comparati con quelli dei Paesi paragonabili per assetto economico sociale sia occidentali (USA, Canada) che asiatici (Giappone, Corea del Sud, Singapore etc).
Le conclusioni sono di stretta attualità in relazione alle riflessioni oggi in corso sul futuro del nostro continente. L’Europa deve affrontare una sfida in termini di equità, per quanto riguarda i livelli bassi di apprendimento, ma anche in termini di eccellenza, per quanto riguarda i risultati di alto livello. Perché dal paragone esce male, anche se naturalmente con significative differenziazioni al suo interno: il 30% degli studenti UE ottiene risultati sotto il livello considerato di accettabilità in Matematica ed il 25% in Lettura e Scienze, la metà degli studenti provenienti da famiglie di ESCS (livello economico-sociale) basso ottiene risultati di questo tipo in Matematica, meno di uno su dieci è top performer (ottiene risultati buoni o eccellenti) in almeno uno dei tre campi indagati. Registrando in tal modo un gap significativo con i risultati dei Paesi sopra citati, soprattutto quelli di area asiatica.
Un livello di vita apicale, molta ricchezza sedimentata, ma un futuro quantomeno incerto, se il livello degli apprendimenti predice qualcosa, ed a quanto pare lo fa.



