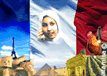TERZA PARTE
La sfida della laicità (I)
 Tra Luglio e Dicembre 2003, la commissione ha condotto un centinaio di audizioni pubbliche e una quarantina di audizioni a porte chiuse. Essa ha fatto la scelta di ascoltare tanto responsabili politici, religiosi, sindacali, amministrativi, associativi quanto eletti negli enti locali, imprenditori, capi d'istituto, professori, direttori d'ospedale e di prigione, infermieri. È stato organizzato un dibattito pubblico con 220 allievi di licei franciliesi e francesi all'estero che avevano preliminarmente lavorato sulla laicità. La commissione si è anche spostata in vari Paesi europei per mettere a confronto l'esperienza francese con quella dei nostri partners. Essa ha, infine, ricevuto parecchie centinaia di contributi scritti. Nei suoi sei mesi di esistenza, si è curata di dare ascolto al più largo ventaglio d'opinioni che hanno avuto modo d'esprimersi nel corso del dibattito.
Tra Luglio e Dicembre 2003, la commissione ha condotto un centinaio di audizioni pubbliche e una quarantina di audizioni a porte chiuse. Essa ha fatto la scelta di ascoltare tanto responsabili politici, religiosi, sindacali, amministrativi, associativi quanto eletti negli enti locali, imprenditori, capi d'istituto, professori, direttori d'ospedale e di prigione, infermieri. È stato organizzato un dibattito pubblico con 220 allievi di licei franciliesi e francesi all'estero che avevano preliminarmente lavorato sulla laicità. La commissione si è anche spostata in vari Paesi europei per mettere a confronto l'esperienza francese con quella dei nostri partners. Essa ha, infine, ricevuto parecchie centinaia di contributi scritti. Nei suoi sei mesi di esistenza, si è curata di dare ascolto al più largo ventaglio d'opinioni che hanno avuto modo d'esprimersi nel corso del dibattito.
Le analisi che seguono sono il frutto della ricerca condotta in comune dai venti membri della commissione, loro stessi rappresentativi di sensibilità e settori di esperienza fra i più ampi. Tali analisi testimoniano la sfida con cui oggi la laicità si confronta.
Di fronte a un nuovo contesto sociale e spirituale, la laicità ha saputo rispondere con l'affermazione del principio di eguaglianza su cui si fonda. Ma numerose questioni non risolte la mettono oggi in pericolo, così come in pericolo altri valori fondanti del patto sociale.
Dall'eguaglianza giuridica all'eguaglianza sostanziale: alcuni progressi
Di fronte alla nuova diversità spirituale e religiosa, la pratica della laicità ha cominciato ad adeguarsi. L'obiettivo prioritario d'eguaglianza fra tutte le opzioni rappresenta un processo di lunga durata, non ancora compiuto.
Tener conto di tutte le convinzioni spirituali o religiose
La laicità è una pratica viva. I pubblici poteri hanno saputo tener conto, in certi settori, delle preoccupazioni e dei nuovi bisogni espressi in materia spirituale o religiosa. Quindici anni fa, i contenuti delle rivendicazioni riguardavano la creazione di nuovi luoghi di culto, moschee, sinagoghe o pagode. Oggi si estendono ad altri campi: i menù nella ristorazione collettiva, il rispetto di esigenze legate alle principali feste religiose, o l' insegnamento dei fenomeni religiosi. Alcune risposte sono state date applicando la legge del 1905 o, quando questa non può essere di aiuto, ricercando dei «compromessi ragionevoli».
Le municipalità frappongono meno ostacoli rispetto a un tempo all'edificazione di nuovi luoghi di culto. Le autorizzazioni urbanistiche sono concesse più facilmente. Alcune comunità locali hanno sostenuto la costruzione di edifici di culto mettendo a disposizione terreni comunali nel quadro di contratti d'affitto enfiteutico o facendosi garanti di prestiti. Gli interventi in questo settore non sono tuttavia omogenei. È in ogni caso chiaro che se l'articolo 2 della legge 9 Dicembre 1905 vieta il finanziamento pubblico degli edifici di culto, questo non significa che se ne debba impedire la costruzione.
Allo stesso modo, i pubblici poteri cercano di tener conto delle esigenze legate all'organizzazione delle grandi feste religiose. In occasione di tali celebrazioni, come quelle dell'Aïd-el-Kebir o del Kippur, sono messi a disposizione locali di organizzazioni comunitarie, per rimediare all'insufficiente capacità d'accoglienza dei luoghi di culto esistenti. Il calendario di tutte le feste religiose è trasmesso ogni anno a tutte le amministrazioni e in tali ricorrenze possono essere concesse autorizzazioni ad assentarsi. Infine, la macellazione connessa ai riti religiosi comincia ad esser meglio garantita.
Le amministrazioni prendono in considerazione, ora più che in passato, i veti alimentari legati a convinzioni religiose. I responsabili delle mense scolastiche, gli ospedali e le prigioni si curano di predisporre, nella misura del possibile, menù diversificati.
Infine l'insegnamento dei fenomeni religiosi, nell'ambito delle materie umanistiche, è presente nei programmi scolastici secondo i nuovi orientamenti di francese e di storia, per le classi del primo e secondo anno della scuola secondaria inferiore e del primo e secondo anno della scuola secondaria superiore. Bisogna d'altronde ricordare che, a aprtire dalla III° Repubblica, le grandi questioni relative alle religioni antiche, medievali e moderne hanno sempre avuto posto nei programmi.
Perseguire miglioramenti
L'attuazione del principio di laicità non ha ancora consentito di colmare i deficit d'eguaglianza tra credenti o tra credenti ed atei.
Nell'espressione del pensiero
Certi genitori sono contrari ad iscrivere i loro figli in scuole confessionali, in assenza di scuole pubbliche nel loro comune. Rispetto alle Chiese, le correnti che si richiamano al libero pensiero e alla filosofia razionalista non dispongono di un eguale accesso alle trasmissioni televisive del servizio pubblico, contrariamente a ciò che avviene in altri Paesi europei.
Nell'esercizio di convinzioni personali
Anche quando l'assenza è compatibile col funzionamento del servizio, è talvolta difficile prendere un giorno di congedo per il Kippur, l'Aid-el-Kebir o in occasione di altre feste religiose. Allo stesso modo, accade ancora che a scuola siano fissati compiti in classe nei giorni delle grandi feste religiose, privando coloro che sono stati autorizzati ad assentarsi della possibilità di parteciparvi.
Non vi sono sufficienti cappellani musulmani né nelle prigioni né negli ospedali; non ve ne sono nell'esercito, né negli istituti scolastici. È vero che in assenza di strutture di rappresentanza dell'Islam l'amministrazione non aveva interlocutori per proporre loro dei cappellani musulmani.
Nel rispetto delle cerimonie funebri
La vestizione funebre dei morti, per esempio negli ospedali, non è sempre assicurata nel rispetto delle regole religiose, anche quando queste sono compatibili con le necessità dell'ordine pubblico e con gli obblighi di servizio. Infine, è talvolta impossibile sepellire i morti in conformità con le diverse tradizioni religiose e nel rispetto delle leggi della Repubblica. ![]()