Rosario Drago
intervento 1a questione (II)
Scuola contro lavoro
a) La sciagurata separazione del diritto allo studio dal diritto al lavoro

Ha ragione Norberto Bottani a rimproverare al nostro sistema la separazione sciagurata del diritto allo studio dal diritto al lavoro. Tale separazione assume anche l'aspetto di un contrasto polemico tra l'aula e il laboratorio nelle retoriche pedagogiche e addirittura in quella sindacale (il lavoro assimilato a sfruttamento, ignoranza, abbrutimento, subordinazione al padrone, ecc.). Su questa linea, che non sarà mai abbastanza contestata, si sono prese iniziative che hanno contribuito in modo definitivo a consolidare i meccanismi di disuguaglianza e iniquità tra i cittadini studenti.
E' bene ricordarli:
• eliminata ogni didattica operativa fin dalla scuola media (la lezione continua ad occupare il suo posto di prestigio, come c'informa Gasperoni), dopo il fallimento delle poco gloriose “applicazioni tecniche”. Ma potremmo discutere anche di come si studiano la musica, le scienze, l'arte, ecc.
• ridotti all'osso gli orari dei laboratori anche negli istituti tecnici e professionali: in pochi anni siamo passati, ad esempio nel biennio, da venti ore ad un massimo di 3/6 ore, per lasciare posto a materie teoriche come diritto, ecc.
• quasi scomparse le attività “per conto terzi” dagli istituti tecnici e professionali (rimaste negli indirizzi similari in tutti i sistemi scolastici europei), che hanno rappresentato per decenni, nel Dopoguerra, il legame più fecondo tra la formazione dei ragazzi, l'aggiornamento degli insegnanti, l'innovazione dei processi produttivi nelle piccole e medie aziende (il vero “territorio”);
Questo processo ha costituito la premessa del distacco definitivo tra la scuola che si fa in aula e il mondo del lavoro.
Così il nostro continua ad essere un Paese in cui i saperi professionali si collocano molto in basso nella gerarchia del prestigio sociale e in cui tra le diverse culture continuano a sussistere robusti steccati. Ci sono barriere tra la cultura umanistica e quella tecnico scientifica, tra saperi teorici e pratici, tra i procedimenti conoscitivi induttivi e deduttivi, tra i diversi tipi di intelligenza, tra il sapere e il saper fare.
Questa separazione è la radice dell'ineguaglianza, perché non consente il riconoscimento concreto, nel fare scuola, di intelligenze diverse. Quindi un grave limite alla democrazia “didattica” ed educativa.
b) Formazione scolastica e formazione professionale fra due estremi
 Integrare la formazione scolastica con la formazione professionale può voler dire, dunque, molte cose diverse che si collocano tra due estremi.
Integrare la formazione scolastica con la formazione professionale può voler dire, dunque, molte cose diverse che si collocano tra due estremi.
Ad un estremo la necessità di:
• abbattere gli attuali steccati
• riconnettere la teoria alla pratica più di quanto le strutture scolastiche da sole sarebbero in grado di fare;
• far dialogare insegnanti della scuola e della formazione professionale interrogandosi gli uni e gli altri sui nessi che esistono tra i loro differenti saperi;
• dare agli studenti la possibilità di ritornare alla teoria attraverso le domande che l'operatività suscita continuamente , con la sua cogenza a risolvere problemi empirici;
• mettere, in estrema sintesi, gli studenti in condizione di sviluppare tutte le loro potenzialità, comprese quelle che mal si manifestano davanti a un libro, a una penna e a un foglio.
All'altro estremo la volontà di:
• approfondire gli attuali steccati
• delegare agli insegnanti della formazione professionale il “modesto” compito di addestrare i giovani a usare macchine ed attrezzi;
• separare, più nettamente di quanto già non avvenga, la teoria dalla pratica;
• aggiungere a curricoli già faticosi per numero di materie e ore, altre attività , nella smania di rincorrere tecniche e tecnologie in perpetuo cambiamento.
Credo che la seconda soluzione debba essere decisamente respinta, ma non lo è perchè costa poca fatica a tutti, ed è la più semplice da realizzare.
c) Il quasi fallimento degli stage
 E' giusto ricordare che sono stati fatti anche alcuni tentativi di migliorare il rapporto con il mondo del lavoro. Si tratta degli stage aziendali , di cui però si possono dare letture molto diverse. Succede infatti che la storica diffidenza degli insegnanti verso il mondo del lavoro e la rivendicazione puntigliosa della propria autonomia e superiorità, può trasformarsi nel suo contrario: nella subordinazione del proprio progetto formativo alla domanda dell'impresa, nell'accettazione di un ruolo surrettizio di addetti alla selezione del personale. Nell'oscillare tra questi due estremi, lo stage spesso risulta un'appendice, un corpo estraneo che si aggiunge all'esperienza scolastica senza interrogarla, o un'anticipazione della socializzazione al lavoro senza il sostegno cognitivo di un lavoro scolastico capace di interrogare criticamente l'esperienza di lavoro. In entrambi i casi l'esperienza di stage aziendale difficilmente aiuta i giovani a ritrovare, o a sostenere, la motivazione allo studio, stante la separatezza tra l'una e l'altro e la subordinazione del secondo alla prima.
E' giusto ricordare che sono stati fatti anche alcuni tentativi di migliorare il rapporto con il mondo del lavoro. Si tratta degli stage aziendali , di cui però si possono dare letture molto diverse. Succede infatti che la storica diffidenza degli insegnanti verso il mondo del lavoro e la rivendicazione puntigliosa della propria autonomia e superiorità, può trasformarsi nel suo contrario: nella subordinazione del proprio progetto formativo alla domanda dell'impresa, nell'accettazione di un ruolo surrettizio di addetti alla selezione del personale. Nell'oscillare tra questi due estremi, lo stage spesso risulta un'appendice, un corpo estraneo che si aggiunge all'esperienza scolastica senza interrogarla, o un'anticipazione della socializzazione al lavoro senza il sostegno cognitivo di un lavoro scolastico capace di interrogare criticamente l'esperienza di lavoro. In entrambi i casi l'esperienza di stage aziendale difficilmente aiuta i giovani a ritrovare, o a sostenere, la motivazione allo studio, stante la separatezza tra l'una e l'altro e la subordinazione del secondo alla prima.
Queste iniziative dovrebbero essere ripensate a fondo, soprattutto avendo in mente che per un buon numero di giovani andare a lavorare rappresenta un valore: significa diventare grandi, farla finita con una esperienza scolastica mediocre e frustrante, acquistare indipendenza dalla famiglia, uscire da un'adolescenza vissuta stentatamente, anche se il lavoro non è di per sé un'esperienza educativa e ha bisogno della scuola.
La scuola giudicante
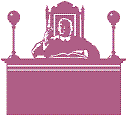 A questi fatti fondamentali, si deve aggiungere che, soprattutto in Italia, il lavoro scolastico ha un carattere eminentemente valutativo . I ragazzi vengono chiamati a realizzare prestazioni la cui qualità viene valutata dai docenti sia attraverso procedure altamente discrezionali (perduta finora la battaglia da Gattullo a Vertecchi per introdurre prove più obiettive ed eque), sia attraverso vari tipi di segnali verbali e non verbali (tono di voce, sguardo, messaggi di incoraggiamento e di stigmatizzazione). La valutazione non riguarda solo i fenomeni normali di verifica, gli esami, ma permea l'insieme delle attività scolastiche.
A questi fatti fondamentali, si deve aggiungere che, soprattutto in Italia, il lavoro scolastico ha un carattere eminentemente valutativo . I ragazzi vengono chiamati a realizzare prestazioni la cui qualità viene valutata dai docenti sia attraverso procedure altamente discrezionali (perduta finora la battaglia da Gattullo a Vertecchi per introdurre prove più obiettive ed eque), sia attraverso vari tipi di segnali verbali e non verbali (tono di voce, sguardo, messaggi di incoraggiamento e di stigmatizzazione). La valutazione non riguarda solo i fenomeni normali di verifica, gli esami, ma permea l'insieme delle attività scolastiche.
E la valutazione è pubblica (perduta anche l'antica battaglia per ridurre il peso delle interrogazioni, come tribunali senza appello), avviene in presenza di compagni che sono essi stessi coinvolti nei processi di valutazione. Ad essere messe in gioco non sono solo le prestazioni scolastiche e i relativi risultati, ma l'intera personalità degli allievi e il loro senso di autostima. Se ricompense e punizioni in senso stretto arrivano a intervalli più o meno lunghi nel tempo, l'ansia e il timore di essere puniti colorano l'intera esperienza scolastica di tutti gli studenti, compresi quelli che ottengono mediamente buoni risultati.
“Tolerance for education”
 Un altro fattore, che è necessario introdurre in questo tipo di analisi, è ciò che gli inglesi chiamano tolerance for education. Si tratta di una sorta di “accettazione e adattamento” nei confronti delle condizioni imposte dalla scuola, che gli studenti esprimono a livelli molto diversi a seconda della loro origine sociale. La tolerance for education è particolarmente sviluppata in chi ha un alto livello di aspirazioni sociali e professionali e legami interpersonali, soprattutto familiari, che incitano e aiutano a tollerare lo stress della scuola, dei suoi riti e delle sue regole,per progredire nella carriera scolastica. Lo è molto meno, fino a diventare insignificante, fra i ceti bassi, che non trovano motivazioni altrettanto forti per sopportare e adattarsi al conformismo delle regole scolastiche.
Un altro fattore, che è necessario introdurre in questo tipo di analisi, è ciò che gli inglesi chiamano tolerance for education. Si tratta di una sorta di “accettazione e adattamento” nei confronti delle condizioni imposte dalla scuola, che gli studenti esprimono a livelli molto diversi a seconda della loro origine sociale. La tolerance for education è particolarmente sviluppata in chi ha un alto livello di aspirazioni sociali e professionali e legami interpersonali, soprattutto familiari, che incitano e aiutano a tollerare lo stress della scuola, dei suoi riti e delle sue regole,per progredire nella carriera scolastica. Lo è molto meno, fino a diventare insignificante, fra i ceti bassi, che non trovano motivazioni altrettanto forti per sopportare e adattarsi al conformismo delle regole scolastiche.
Oltre l'ingegneria istituzionale
 L'ingegneria istituzionale ha cercato di dare risposta alle disuguaglianze sociali rendendo aperti i sistemi educativi, ridistribuendo le opportunità di apprendimento nel corso della carriera scolastica. A questo obiettivo rispondono le passate riforme e quella odierna con provvedimenti quali:
L'ingegneria istituzionale ha cercato di dare risposta alle disuguaglianze sociali rendendo aperti i sistemi educativi, ridistribuendo le opportunità di apprendimento nel corso della carriera scolastica. A questo obiettivo rispondono le passate riforme e quella odierna con provvedimenti quali:
• innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione
• reversibilità delle scelte scolastiche attraverso meccanismi di “crediti” spendibili in questo o quel percorso, senza eccessive penalizzazioni nel passaggio da un canale all'altro.
Questa scelte, a leggere le più recenti riforme europee, non hanno funzionato: tanto che alcuni studiosi sono arrivati a conclusioni opposte. Sarebbe proprio il modello di scuola lunga (sempre più lunga), quella che ritarda la scelta di indirizzi professionalizzanti, a scoraggiare i giovani che provengono da famiglie poco scolarizzate dal proseguire gli studi.
Sono convinto, anche per la foga con cui sostengo la priorità da assegnare al concetto di tolerance for education che il problema di garantire a tutti pari opportunità di seguire percorsi lunghi e qualificati di formazione non si risolve con la semplice ingegneria istituzionale. A un'ingegneria istituzionale, che deve sicuramente essere più fine di quella che si limita a definire canali e punti di biforcazione, debbono necessariamente accompagnarsi innovazioni profonde nei contenuti e negli ambienti didattici ed educativi dell'apprendimento, compresa la qualità della vita scolastica dei ragazzi .