ASPETTI METACOGNITIVI

Che cos’è la metacognizione
Per metacognizione si intende l’accesso consapevole e il controllo del proprio pensiero e della propria conoscenza (Flavell, 1970; Brown, 1978; Cornoldi, 1995).
Il funzionamento metacognitivo si sviluppa nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza ((Schneider, 2011). |
Esempi di accesso e controllo della propria conoscenza
Vi riporto un esempio che ho tratto dalla sbobinatura di quello che mi ha detto una bambina di 5^ classe primaria, nel corso di una mia collaborazione con l’insegnante nel campo dell’educazione scientifica. Il nostro scopo era fare diventare l’apprendimento delle scienze coinvolgente a livello cognitivo motivazionale. Avevamo messo dei cubetti di ghiaccio in contenitori diversi: in una teiera d’acciaio, in un vasetto di vetro, in una scatola di polistirolo tipo gelato, e in un maglione di lana. |
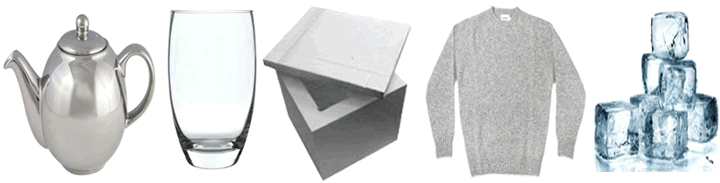 |
Abbiamo fatto prevedere ai bambini in quale contenitore si sarebbe sciolto prima il cubetto di ghiaccio. Nelle due classi che io ho frequentato, tutti avevano previsto, come potete immaginare, che i cubetti si sarebbero sciolti prima nel maglione di lana, perché nel linguaggio quotidiano il maglione tiene caldo. Ora leggiamo cosa dice questa bambina di 5^ primaria, perché è un esempio splendido di metacognizione, esternalizza il suo pensiero come se lo avesse in mano. |
|
Dice: “E’ strano io non riesco a capire”, si rende cioè conto che c'è un problema di conoscenza, ma vuole anche risolverlo. L'insegnante non ha anticipato la spiegazione dicendo “ma la lana è ...”, ha lasciato che ci arrivassero i bambini. Ha rispettato cioè il loro percorso cognitivo, e questo succede se l'insegnante è consapevole dell'importanza di questi processi. |
In conclusione
|
 “Io ci sto riflettendo ma non riesco a capire una cosa, quello che ho visto con i miei occhi durante un esperimento mi pare davvero incredibile, ma voglio mettermelo in testa.
“Io ci sto riflettendo ma non riesco a capire una cosa, quello che ho visto con i miei occhi durante un esperimento mi pare davvero incredibile, ma voglio mettermelo in testa. E’ possibile potenziare a scuola la conoscenza / consapevolezza metacognitiva (Mason & Gava, 2007; Thomas & McRobbie, 2001).
E’ possibile potenziare a scuola la conoscenza / consapevolezza metacognitiva (Mason & Gava, 2007; Thomas & McRobbie, 2001).