Relazione di Carlo Marzuoli
Ordinario di Diritto Amministrativo
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze
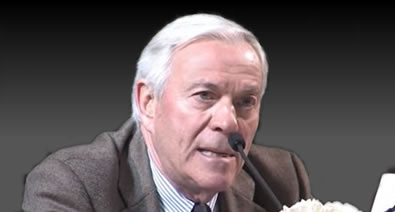
Introduzione: il problema.
Un sentito ringraziamento per l’invito. Convegni come questo sono iniziative importanti: permettono un confronto con esperienze reali e offrono la possibilità di verificare e riflettere sul rapporto intercorrente fra le istituzioni come devono essere e le istituzioni come sono. È una dimensione indispensabile per comprendere, anche dal punto di vista giuridico e istituzionale, i problemi dell’istruzione. Un Maestro era solito affermare che la prima esigenza da soddisfare, quando si devono esaminare questioni giuridiche (per elaborare delle norme o per risolvere delle controversie), è la conoscenza dei fenomeni, dei fatti che pongono il problema giuridico. I fatti, in questo caso sono la Vostra esperienza, gli anni di studio e di lavoro di Bruno Ciari e quelli di tantissimi altri (docenti o studiosi) impegnati nel mondo della scuola. |
Il rapporto fra scuola e struttura pluralistica della Repubblica
|
L’esigenza di coerenza istituzionale
|
La scuola dell’infanzia è scuola
|
Scuola e autonomia scolastica nell’art. 117 della Costituzione
Le implicazioni sono numerose. L’istruzione ha un’identità e un regime giuridico apposito dal punto di vista del riparto delle competenze fra gli enti che costituiscono (art. 114 Cost.) a Repubblica (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato), competenze diverse che sono diverse ma convergenti ai fini della regolamentazione e del funzionamento della scuola, e vanno dalle norme generali sull’istruzione (allo Stato) fino all’autonomia delle istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito dall’art. 117. |
Principio di coerenza e passaggio all’ASP (Azienda pubblica di servizi alla persona)
Dato il contesto, è difficile immaginare che il principio di coerenza possa essere adeguatamente rispettato nel caso di incardinamento della scuola in una struttura amministrativa come l’Azienda di Servizi alla Persona (di cui di recente la L.R. n. 12/2013, contenente “Norme ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona”), che diversa dell’istituzione politica di riferimento (il Comune, nel caso) e creata appositamente per gestire compiti da tenere necessariamente distinti e separati da quelli della scuola. |
Un legislatore su cui vigilare (il D.L. n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013)
|
Una prospettiva da recuperare
|
La proliferazione delle “Amministrazioni parallele”
|
La scuola della Repubblica non è scuola dello Stato. E’ scuola “nazionale”
|
 L’alternativa che si pone in questo momento per le scuole dell’infanzia del Comune di Bologna deriva da aspetti di ordine più generale, che rimandano al concreto rapporto fra due distinte entità giuridiche e istituzionali, che sono il pilastro dello Stato democratico. Da un lato vi è la scuola, con la sua insopprimibile identità (si comincia con gli articoli 33 e 34 Cost. e si giunge all’art. 117 Cost.: l’istruzione e l’istruzione e formazione professionale, le norme generali sull’istruzione, i livelli essenziali delle prestazioni dell’istruzione, l’autonomia scolastica), e dall’altro la struttura pluralistica della Repubblica. La riforma costituzionale del 2001, pur con tutti i limiti e i difetti, su un aspetto almeno fa definitiva chiarezza: la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Il consolidamento – fermo il rispetto della Costituzione – di una diffusa e partecipata organizzazione delle modalità di esercizio (e di presenza) della sovranità popolare dovrebbe più facilmente costringere le istituzioni e le amministrazioni a corrispondere ai bisogni dei cittadini e, innanzitutto, a meglio interpretarli e a contribuire in modo più efficace alla valorizzazione delle esperienze che maturano nella comunità.
L’alternativa che si pone in questo momento per le scuole dell’infanzia del Comune di Bologna deriva da aspetti di ordine più generale, che rimandano al concreto rapporto fra due distinte entità giuridiche e istituzionali, che sono il pilastro dello Stato democratico. Da un lato vi è la scuola, con la sua insopprimibile identità (si comincia con gli articoli 33 e 34 Cost. e si giunge all’art. 117 Cost.: l’istruzione e l’istruzione e formazione professionale, le norme generali sull’istruzione, i livelli essenziali delle prestazioni dell’istruzione, l’autonomia scolastica), e dall’altro la struttura pluralistica della Repubblica. La riforma costituzionale del 2001, pur con tutti i limiti e i difetti, su un aspetto almeno fa definitiva chiarezza: la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Il consolidamento – fermo il rispetto della Costituzione – di una diffusa e partecipata organizzazione delle modalità di esercizio (e di presenza) della sovranità popolare dovrebbe più facilmente costringere le istituzioni e le amministrazioni a corrispondere ai bisogni dei cittadini e, innanzitutto, a meglio interpretarli e a contribuire in modo più efficace alla valorizzazione delle esperienze che maturano nella comunità. Sempre, e perciò anche nel rapporto fra queste due entità giuridiche, scuola e istituzioni politiche, il primo elemento da sottolineare è quello della coerenza istituzionale.
Sempre, e perciò anche nel rapporto fra queste due entità giuridiche, scuola e istituzioni politiche, il primo elemento da sottolineare è quello della coerenza istituzionale. 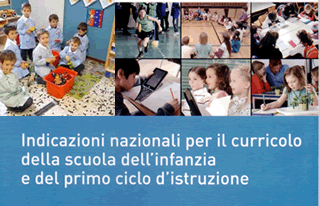 Scuola dell’infanzia. Dove e come incardinarla: come collegarla alle istituzioni rappresentative delle rispettive comunità.
Scuola dell’infanzia. Dove e come incardinarla: come collegarla alle istituzioni rappresentative delle rispettive comunità. 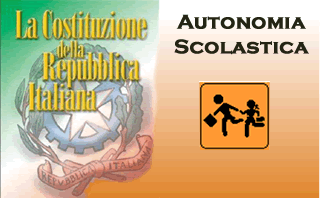 La scuola e l’istruzione, a loro volta, hanno una propria un’individualità giuridica, che trae la sua ragione di essere dalla Costituzione. Di conseguenza, necessitano di un regime giuridico appropriato. Infatti: se una “cosa” è giuridicamente qualificabile come scuola (e non, ad esempio, come assistenza, o come attività imprenditoriale, o come paesaggio, ecc.), deve essere poi ulteriormente disciplinata e regolata in modo coerente con detta qualificazione.
La scuola e l’istruzione, a loro volta, hanno una propria un’individualità giuridica, che trae la sua ragione di essere dalla Costituzione. Di conseguenza, necessitano di un regime giuridico appropriato. Infatti: se una “cosa” è giuridicamente qualificabile come scuola (e non, ad esempio, come assistenza, o come attività imprenditoriale, o come paesaggio, ecc.), deve essere poi ulteriormente disciplinata e regolata in modo coerente con detta qualificazione.  La ragione di tanta insistenza sull’identità della scuola e in particolare, nel caso, della scuola dell’infanzia è evidente. Se la
La ragione di tanta insistenza sull’identità della scuola e in particolare, nel caso, della scuola dell’infanzia è evidente. Se la  In tema di coerenza (o incoerenza) di un sistema giuridico e istituzionale il primo attore è il legislatore. L’esperienza dimostra che non è affidabile come si vorrebbe e dunque deve essere oggetto di permanente vigilanza (perché comunque con il legislatore si debbono fare i conti).
In tema di coerenza (o incoerenza) di un sistema giuridico e istituzionale il primo attore è il legislatore. L’esperienza dimostra che non è affidabile come si vorrebbe e dunque deve essere oggetto di permanente vigilanza (perché comunque con il legislatore si debbono fare i conti).  Dopo decenni di esperienze scolastiche, culturali, lavorative e di evoluzione legislativa che ci dicono che la scuola dell’infanzia è scuola, non è accettabile (per un minimo di coerenza istituzionale) che, per effetto di due parole spuntate in un decreto legge, pur se convertito, si possa ritenere sovvertito e ribaltato un sistema giuridico e istituzionale consolidato. Si può certo cambiare, ma non con la fiammata di un comma. Non è possibile che un legislatore con la mano destra improvvisi una norma in netto contrasto con ciò che con la mano sinistra ha scritto con un percorso di decenni, per di più se quest’ultimo è anche il legislatore costituzionale. A coerenza (di ciò che sta prima) deve corrispondere coerenza (di ciò che sta dopo).
Dopo decenni di esperienze scolastiche, culturali, lavorative e di evoluzione legislativa che ci dicono che la scuola dell’infanzia è scuola, non è accettabile (per un minimo di coerenza istituzionale) che, per effetto di due parole spuntate in un decreto legge, pur se convertito, si possa ritenere sovvertito e ribaltato un sistema giuridico e istituzionale consolidato. Si può certo cambiare, ma non con la fiammata di un comma. Non è possibile che un legislatore con la mano destra improvvisi una norma in netto contrasto con ciò che con la mano sinistra ha scritto con un percorso di decenni, per di più se quest’ultimo è anche il legislatore costituzionale. A coerenza (di ciò che sta prima) deve corrispondere coerenza (di ciò che sta dopo).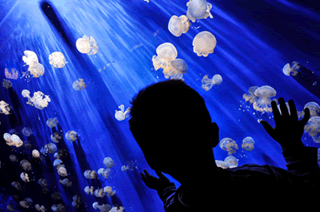 Il secondo profilo va ben oltre le restrizioni dettate dalla crisi; si tratta di un problema di ordine assolutamente generale e di lungo periodo. Gli enti pubblici costituzionalmente necessari come Comuni, Province , Città Metropolitane, Regioni, e Stato sono assoggettati a determinati principi perché sono, intrinsecamente e inequivocabilmente, “pubblici”. Costituiscono la forma giuridica che organizza, rappresenta e fa vivere la popolazione di riferimento. Di conseguenza sono regolati da principi derivanti da tale loro natura: imparzialità, trasparenza, buon andamento, controllabilità, ecc.
Il secondo profilo va ben oltre le restrizioni dettate dalla crisi; si tratta di un problema di ordine assolutamente generale e di lungo periodo. Gli enti pubblici costituzionalmente necessari come Comuni, Province , Città Metropolitane, Regioni, e Stato sono assoggettati a determinati principi perché sono, intrinsecamente e inequivocabilmente, “pubblici”. Costituiscono la forma giuridica che organizza, rappresenta e fa vivere la popolazione di riferimento. Di conseguenza sono regolati da principi derivanti da tale loro natura: imparzialità, trasparenza, buon andamento, controllabilità, ecc. 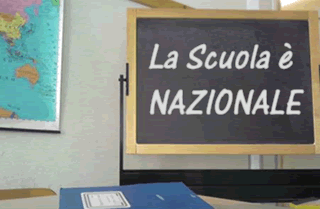 La scuola della Repubblica, infatti, non è scuola dello Stato. E’ scuola “nazionale”, cioè un insieme istituzionale necessariamente collegato al complesso delle altre istituzioni politiche. La Regione e il potere locale sono chiamati a misurarsi (quanto meno dal 2001, riforma del Titolo V) con i problemi della scuola come tale, scuola dell’infanzia compresa. Misurarsi con la scuola significa affrontare in primo luogo il tema della condizione giuridica dei titolari della funzione docente, che non cambia quale che sia il luogo in cui si esercita e quale che sia il datore di lavoro, che potrebbe (dovrebbe) ristrutturarsi abbandonando l’esclusivo riferimento allo Stato. La identità dello statuto del docente, infatti, è – a ben vedere – una delle essenziali ragioni fondanti l’autonomia scolastica, di ogni scuola. Questa è la prima coerenza da rispettare, su tutti i piani, a tutti gli effetti.
La scuola della Repubblica, infatti, non è scuola dello Stato. E’ scuola “nazionale”, cioè un insieme istituzionale necessariamente collegato al complesso delle altre istituzioni politiche. La Regione e il potere locale sono chiamati a misurarsi (quanto meno dal 2001, riforma del Titolo V) con i problemi della scuola come tale, scuola dell’infanzia compresa. Misurarsi con la scuola significa affrontare in primo luogo il tema della condizione giuridica dei titolari della funzione docente, che non cambia quale che sia il luogo in cui si esercita e quale che sia il datore di lavoro, che potrebbe (dovrebbe) ristrutturarsi abbandonando l’esclusivo riferimento allo Stato. La identità dello statuto del docente, infatti, è – a ben vedere – una delle essenziali ragioni fondanti l’autonomia scolastica, di ogni scuola. Questa è la prima coerenza da rispettare, su tutti i piani, a tutti gli effetti.