L'influenza del positivismo in campo educativo
 Nel corso della seconda metà dell'Ottocento il positivismo italiano ha dato un incremento particolare agli studi di pedagogia e alla scuola. Nel 1870 Roberto Ardigò, il maggiore rappresentante di questo orientamento, pubblica La psicologia come scienza positiva, da cui si fa iniziare l'avvio della psicologia moderna in Italia. Il positivismo italiano ha rappresentato, rispetto ad altri Paesi europei, non solo un orientamento filosofico e scientifico, ma anche letterario e artistico, esprimendosi, infine, in un ethos largamente condiviso. La sua influenza è penetrata, dunque, in tutta la cultura; esso ha svolto un ruolo egemonico nella cultura italiana nella seconda metà dell'Ottocento, concorrendo a stabilire un'unità del ceto intellettuale borghese.
Nel corso della seconda metà dell'Ottocento il positivismo italiano ha dato un incremento particolare agli studi di pedagogia e alla scuola. Nel 1870 Roberto Ardigò, il maggiore rappresentante di questo orientamento, pubblica La psicologia come scienza positiva, da cui si fa iniziare l'avvio della psicologia moderna in Italia. Il positivismo italiano ha rappresentato, rispetto ad altri Paesi europei, non solo un orientamento filosofico e scientifico, ma anche letterario e artistico, esprimendosi, infine, in un ethos largamente condiviso. La sua influenza è penetrata, dunque, in tutta la cultura; esso ha svolto un ruolo egemonico nella cultura italiana nella seconda metà dell'Ottocento, concorrendo a stabilire un'unità del ceto intellettuale borghese.
 Questo orientamento ha dato un apporto originale e innovativo nella creazione di istituzioni educative al di fuori di quelle statali. In particolare, va segnalata l'attività di Maria Montessori.
Questo orientamento ha dato un apporto originale e innovativo nella creazione di istituzioni educative al di fuori di quelle statali. In particolare, va segnalata l'attività di Maria Montessori.
"Nella storia dell'educazione", ha affermato Renato Tisato,"l'età del positivismo costituisce un momento d'importanza decisiva. Non c'è settore del campo che non sia profondamente scavato e nel quale non siano attuate, o proposte, trasformazioni radicali: dalla scuola materna a quelle differenziali per subnormali e disadattati, alle secondarie di vario ordine e grado, all'università; dal problema dei fini a quelli del metodo, del contenuto della disciplina, dei sussidi didattici, dei rapporti fra istituzioni scolastiche ed esigenze della nuova società".
Dunque, la pedagogia è un campo in cui il positivismo italiano ha condotto ricerche, prodotto studi teorici e sviluppato una pratica educativa di notevole rilievo, in sintonia con analoghi sviluppi in altri Paesi europei.
In conclusione, i pedagogisti positivisti sono convinti della capacità trasformatrice della cultura moderna degli uomini e perciò della società, e in questa direzione un ruolo essenziale è assegnato a una scuola rinnovata nei metodi, nei programmi e con insegnanti preparati. L'educazione laica si incardina in uno sviluppo della società che è già in atto, pertanto il positivismo propugna una rivoluzione pacifica che accompagni e consolidi tale progresso: una rivoluzione pacifica sì, ma pur sempre rivoluzione, che va contro orientamenti sorpassati e una pratica educativa arcaica.
La questione cattolica
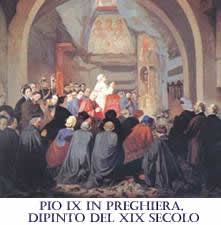 Uno dei problemi che dovette affrontare la classe dirigente post-unitaria, fu il rapporto con la Chiesa. Dopo la proclamazione dell'unità d'Italia, la Chiesa di Pio IX con il "non expedit" pose il "mondo cattolico" al di fuori della vita politica nazionale, dal momento che considerò l'unità d'Italia un tramite di laicizzazione, ossia di "scristianizzazione" delle masse. In una tale prospettiva si comprende il poderoso sforzo compiuto nel campo educativo dal movimento cattolico, dopo l'astensione dalla vita politica
Uno dei problemi che dovette affrontare la classe dirigente post-unitaria, fu il rapporto con la Chiesa. Dopo la proclamazione dell'unità d'Italia, la Chiesa di Pio IX con il "non expedit" pose il "mondo cattolico" al di fuori della vita politica nazionale, dal momento che considerò l'unità d'Italia un tramite di laicizzazione, ossia di "scristianizzazione" delle masse. In una tale prospettiva si comprende il poderoso sforzo compiuto nel campo educativo dal movimento cattolico, dopo l'astensione dalla vita politica
parlamentare, in una direzione che lascia "intravedere il formarsi parallelo di un tessuto educativo-culturale a livello popolare, estraneo al sistema scolastico pubblico e ai circuiti della cultura nazionale, per il fatto che in genere quelle stesse istituzioni economiche e sociali (proposte dai cattolici) alimentavano attività di scuole serali, circoli di lettura, di diffusione di buona stampa e di buoni libri" (Traniello, 1993).
Ora, uno dei paradossi della storia italiana, è che le classi dirigenti liberali mentre attribuirono un ruolo decisivo alla scuola, cui assegnarono il compito di unificazione culturale del Paese, prefigurando un modello etico-civile laico per contrastare le posizioni assunte dalla Chiesa, non fornirono né un'adeguata legislazione nè contributi finanziari sufficienti per raggiungere risultati duraturi.
Di fronte a questa latitanza dello Stato, si ebbe così, nel corso del secondo Ottocento e oltre, una ricchezza di interventi di associazioni di diversa formazione culturale e politica che svolsero un lavoro enorme per l'alfabetizzazione del popolo, per assicurare una prima istruzione, tanto che si può dire che svolsero una funzione di supplenza rispetto allo Stato.
La nascita dell'associazionismo professionale alla fine dell'Ottocento
L'associazionismo degli insegnanti con scopi professionali e genericamente sindacali sorge alla fine dell'Ottocento. L'Associazione degli insegnanti tenne a Torino il suo primo congresso nel 1884; oltre a denunciare abusi e soprusi della burocrazia scolastica chiese miglioramenti di carriera e aumenti degli stipendi. I risultati più significativi delle lotte promosse in questo periodo furono i due decreti del 1887 e del 1889, che definirono i criteri di promozione degli insegnanti e le nomine attraverso il concorso. Nel 1898, l 'anno dei moti popolari di Milano, si tenne a Torino il primo congresso dell' Associazione pedagogica, che avviò un nuovo corso nelle rivendicazioni culturali e sindacali degli insegnanti.
 In tale contesto, assunse un ruolo particolare la figura del preside, di cui Francesco De Sanctis fu tra i primi a rivendicare l'importanza. Nel 1874 intervenne in Parlamento reclamando l'istituzione di un "direttore" responsabile della direzione della scuola. "Per me, disse, la garanzia di una buona scuola è un buon direttore . Se questi direttori sono uomini competenti, che abbiano fatto le loro prove, voi dovete dare a essi tutta l'autorità possibile, la facoltà di decidere tutti gli affari locali. È sempre un progresso quando gli affari fioriscano nelle stesse mani dove cominciano, senza bisogno di tanti controlli e controlli di controlli ".
In tale contesto, assunse un ruolo particolare la figura del preside, di cui Francesco De Sanctis fu tra i primi a rivendicare l'importanza. Nel 1874 intervenne in Parlamento reclamando l'istituzione di un "direttore" responsabile della direzione della scuola. "Per me, disse, la garanzia di una buona scuola è un buon direttore . Se questi direttori sono uomini competenti, che abbiano fatto le loro prove, voi dovete dare a essi tutta l'autorità possibile, la facoltà di decidere tutti gli affari locali. È sempre un progresso quando gli affari fioriscano nelle stesse mani dove cominciano, senza bisogno di tanti controlli e controlli di controlli ".
Ma in un Paese come il nostro, giunto ultimo fra i Paesi europei all'unità statale, e perciò privo di valori condivisi, consolidati da pratiche sociali e culturali comuni, al preside si chiese, come a tutti i funzionari dello Stato, in primo luogo il rispetto di norme giuridiche secondo una precisa delimitazione delle sue funzioni; egli era essenzialmente "al servizio della Nazione" in cui una cosa doveva essere certa: la sua fedeltà al potere politico. In altri termini, al preside non si concesse alcuno spazio autonomo di intervento in un campo, come la scuola, che richiedeva invece una capacità di direzione pedagogica, di mediazione di inevitabili differenze e conflitti, una capacità di creare una comunità formativa.