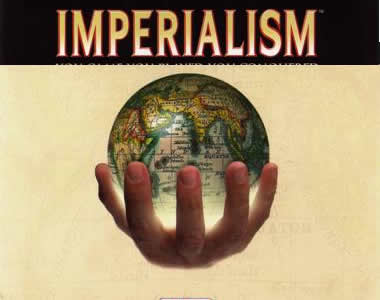Globalizzazione: caratteri del terzo imperialismo
Le analisi della globalizzazione tendono quasi sempre a privilegiare uno o l'altro aspetto del fenomeno; o quello tecnologico, o quello della comunicazione, o quello economico, ecc. A tale proposito l'orientamento più frequente è di scorgere nella globalizzazione un ulterore stadio del capitalismo o dell'imperialismo, con alcuni caratteri accentuati rispetto al modello tradizionale di capitalismo e di imperialismo. La novità risiederebbe, in un caso, nella maggiore mobilità dei processi produttivi, tecnologici e commerciali; nell'altro, in una accentuazione delle differenze fra Paesi ricchi e Paesi poveri, con un ricorso più ampio degli apparati di controllo e di repressione.
 Nel saggio Tre maniere dell'imperialismo (Luciano Vasapolio, a cura di, Il piano inclinato del capitale, Jaca Book, Milano 2003), lo storico del pensiero economico Giorgio Gattei sostiene che il processo di globalizzazione costituisce una rottura rispetto ai modelli di capitalismo e di imperialismo precedenti. In altri termini, siamo di fronte non solo a un allargamento planetario del capitalismo, ma a una vera e propria nuova fase del capitalismo nella storia della modernità, con propri, distinti caratteri rispetto a quelli noti.
Nel saggio Tre maniere dell'imperialismo (Luciano Vasapolio, a cura di, Il piano inclinato del capitale, Jaca Book, Milano 2003), lo storico del pensiero economico Giorgio Gattei sostiene che il processo di globalizzazione costituisce una rottura rispetto ai modelli di capitalismo e di imperialismo precedenti. In altri termini, siamo di fronte non solo a un allargamento planetario del capitalismo, ma a una vera e propria nuova fase del capitalismo nella storia della modernità, con propri, distinti caratteri rispetto a quelli noti.
Le interpretazioni della globalizzazione eludono per di più, di fatto, l'individuazione delle cause di tale fenomeno. D'altra parte, se si ritiene che la globalizzazione sia riducibile ai modelli economici precedenti, sia pure con varianti importanti, le cause saranno quelle già individuate da Marx per il capitalsimo, e da Lenin per l'imperialismo.
Secondo Gattei, al contrario, siamo di fronte a uno stadio del tutto nuovo dell'imperialsmo, che tendenzialmente sta creando un nuovo, radicale assetto planetario. La globalizzazione non è solo un'estensione del modo capitalistico di produzione, come è avvenuto nella prima fase dello sviluppo capitalistico, in cui c'è un centro, rappresentato dai Paesi industrializzati che esportano i manufatti, e una periferia, ossia i Paesi non industrializzati che esportano le materie prime.
Tra Ottocento e Novecento, questa situazione muta radicalmente; il centro assume una funzione diversa rispetto a quella precedente in cui esportava merci: ora esporta capitali, e ciò determina un rapporto tra centro e periferia profondamente diverso da quello precedente. In questa nuova situazione si è instaurato un rapporto a tutto vantaggio del centro, il quale ha esercitato uno sfruttamento economico e commerciale a tutto svantaggio della periferia.
In conclusione, nel periodo del libero scambio i Paesi emergenti producono materie prime per l'esportazione, nel Novecento producono manufatti per il mercato interno.
 La novità destinata a rivoluzionare i rapporti economici, finanziari, politici tra gli Stati, ossia a cambiare radicalmente l'assetto del mondo, consiste nel fatto che ora i Paesi emergenti producono manufatti per l'esportazione, Ciò significa che l'apparato industriale tende sempre più a essere periferico, ossia è la periferia che esporta i manufatti. La Cina e l'India esportano dal centro alla periferia manufatti prodotti a basso prezzo e venduti a basso prezzo; è la Cina che si avvia ad essere l'"officina" del mondo, e il centro sta tendenzialmente rinunciando all'industria. In altri termini, Paesi come la Cina e l'India, a cui se ne stanno associando altri, tendono ad avere il monopolio della produzione di merci, mentre Europa e America sono i centri del consumo delle merci. Insomma: il Terzo mondo si appresta a produrre tutte le merci del mondo.
La novità destinata a rivoluzionare i rapporti economici, finanziari, politici tra gli Stati, ossia a cambiare radicalmente l'assetto del mondo, consiste nel fatto che ora i Paesi emergenti producono manufatti per l'esportazione, Ciò significa che l'apparato industriale tende sempre più a essere periferico, ossia è la periferia che esporta i manufatti. La Cina e l'India esportano dal centro alla periferia manufatti prodotti a basso prezzo e venduti a basso prezzo; è la Cina che si avvia ad essere l'"officina" del mondo, e il centro sta tendenzialmente rinunciando all'industria. In altri termini, Paesi come la Cina e l'India, a cui se ne stanno associando altri, tendono ad avere il monopolio della produzione di merci, mentre Europa e America sono i centri del consumo delle merci. Insomma: il Terzo mondo si appresta a produrre tutte le merci del mondo.
Se questa è la tendenza in atto, ciò non significa, però, che siamo di fronte all'eclissi dell'Occidente, già vagheggiato da filosofi del primo Novecento; fra tutti citiamo il "padre" di questa interpretazione, Oswald Spengler, che nell'opera Il tramondo dell'Occidente (1918) sostenne, appunto, che la società occidentale è giunta nella fase terminale e lo sviluppo della tecnica, che ormai sfugge al controllo dell'uomo, è il segno più evidente di questo declino inarrestabile.
 Oggi, proprio lo sviluppo tecnologico è considerato essenziale per assicurare all'Occidente, ossia all'Europa e all'America, il primato mondiale. Il patrimonio che l'Occidente può esibire come merce di scambio è riassumibile, secondo Samir Amin, sociologo dei Paesi del Terzo mondo, in questi cinque "monopoli":
Oggi, proprio lo sviluppo tecnologico è considerato essenziale per assicurare all'Occidente, ossia all'Europa e all'America, il primato mondiale. Il patrimonio che l'Occidente può esibire come merce di scambio è riassumibile, secondo Samir Amin, sociologo dei Paesi del Terzo mondo, in questi cinque "monopoli":
- • la ricerca scientifica, il che significa, fra l'altro, il monopolio dei brevetti; essa richiede spese così elevate che solo gli Stati Uniti possono sostenere;
- • il denaro, ossia "Il controllo dei flussi finanziari di portata mondiale";
- • l'energia, con l'essenziale possesso oppure il controllo del petrolio;
- • la comunicazione e i media;
- • gli armamenti, in particolare, il controllo della la bomba atomica come deterrenza nei confronti degli altri Paesi. (I cinque monopoli , "La rivista del manifesto", 9 settembre 2000).
 È indubbio che questi sono i campi in cui l'Occidente ha una netta e indiscussa superiorità determinata da un lungo processo storico largamente conosciuto. Se questa è la tendenza di fondo dell'economia mondiale, sono evidenti le ragioni che inducono l'Occidente a potenziare al massimo la ricerca scientifica. Oggi si parla molto di "società della conoscenza"; il che non significa solo la necessità di una diffusa cultura scientifica per far fronte alle sfide economiche del mondo globalizzato, ma che la ricerca scientifica è l'elemento strategico dell'Occidente, il terreno in cui esso si gioca la sua stessa sopravvivenza economica e politica di potenza egemone del mondo. Così, dopo il primo imperialismo delle merci e il secondo del capitale, assistiamo, secondo Gattei, alla nascita dell'imperialismo della scienza e della tecnica.
È indubbio che questi sono i campi in cui l'Occidente ha una netta e indiscussa superiorità determinata da un lungo processo storico largamente conosciuto. Se questa è la tendenza di fondo dell'economia mondiale, sono evidenti le ragioni che inducono l'Occidente a potenziare al massimo la ricerca scientifica. Oggi si parla molto di "società della conoscenza"; il che non significa solo la necessità di una diffusa cultura scientifica per far fronte alle sfide economiche del mondo globalizzato, ma che la ricerca scientifica è l'elemento strategico dell'Occidente, il terreno in cui esso si gioca la sua stessa sopravvivenza economica e politica di potenza egemone del mondo. Così, dopo il primo imperialismo delle merci e il secondo del capitale, assistiamo, secondo Gattei, alla nascita dell'imperialismo della scienza e della tecnica.
 In questo contesto, la posizione dell'Europa e dell'Italia è tuttora incerta; dopo i due referendum sulla Costituzione europea, respinti dalla Francia e dalla Danimarca, l'Europa mantiene un mercato comune integrato e poteri estesi nel campo della politica economica, ma per ora ha di fatto rinunciato a un potere politico comune, e conseguentemente a dotarsi di un esercito europeo. Ciò limita e limiterà ancor di più in futuro il suo peso politico nel mondo. In Italia il governo di centro destra è saldamente alleato agli Stati Uniti sul terreno politico, mentre su quello economico si registra, accanto a velleitarismi protezionistici, una tendenza, specie all'interno del ceto imprenditoriale, verso l'accettazione della nuova situazione, tanto che è in atto un'estesa dislocazione di industrie nei Paesi dell'Europa orientale e finanche in Cina.
In questo contesto, la posizione dell'Europa e dell'Italia è tuttora incerta; dopo i due referendum sulla Costituzione europea, respinti dalla Francia e dalla Danimarca, l'Europa mantiene un mercato comune integrato e poteri estesi nel campo della politica economica, ma per ora ha di fatto rinunciato a un potere politico comune, e conseguentemente a dotarsi di un esercito europeo. Ciò limita e limiterà ancor di più in futuro il suo peso politico nel mondo. In Italia il governo di centro destra è saldamente alleato agli Stati Uniti sul terreno politico, mentre su quello economico si registra, accanto a velleitarismi protezionistici, una tendenza, specie all'interno del ceto imprenditoriale, verso l'accettazione della nuova situazione, tanto che è in atto un'estesa dislocazione di industrie nei Paesi dell'Europa orientale e finanche in Cina.