Globalizzazione: alla ricerca di una definizione
Il termine globalizzazione ha iniziato a circolare nella letteratura economica e sociologica nell'ultimo decennio del Novecento; esso indica un'internazionalizzazione mercantile (di merci), produttiva (investimenti all'estero), finanziaria (movimenti di capitali), tecnologica (trasferimento di tecnologie), culturale (rapporti culturali), e movimenti di persone (migrazioni). La tematica della globalizzazione è stata e rimane al centro di un vasto interesse degli studiosi di diverse discipline, tanto che oggi la letteratura sull'argomento è molto estesa, e parecchie sono le interpretazioni che sono state date, spesso in conflitto tra loro; ma a tutt'oggi nessuna «ha acquisito una autorevolezza indiscussa» (Danilo Zolo, Globalizzazione. Una mappa dei problemi , Laterza, Bari-Roma 2005).
Il significato del termine globalizzazione
La globalizzazione è un fenomeno essenzialmente economico o comprende anche aspetti della vita sociale e culturale? La globalizzazione ha cambiato in modo radicale la nostra esistenza o ha solo accentuato aspetti delle relazioni sociali e individuali pre-esistenti? Ha diffuso i tradizionali dispositivi simbolici, materiali, tecniche e procedure rendendoli fruibili su scala mondiale, o ne ha creato di nuovi? Siamo, cioè, in presenza di una modificazione antropologica o a modificazioni di alcune delle sue caratteristiche storico-antropologiche sviluppate nel corso dei secoli?.
 Queste, e altre ancora sono le domande cui hanno risposto in modi diversi i molti studiosi della globalizzazione: di alcune interpretazioni fondamentali forniamo un'essenziale informazione.
Queste, e altre ancora sono le domande cui hanno risposto in modi diversi i molti studiosi della globalizzazione: di alcune interpretazioni fondamentali forniamo un'essenziale informazione.
Antony Giddens ha definito la globalizzazione «l'intensificazione di relazioni mondiali che collegano tra loro località molto lontane», determinando tra loro una stretta interdipendenza. Egli ha poi delineato gli effetti che questo assetto unificato del mondo producono nella condizione umana; primo fra tutti nella famiglia, in cui i legami tradizionali non valgono più, e ciò determina una sua grande instabilità (Le conseguenze della modernità: fiducia e rischio, sicurezza e pericolo , il Mulino, Bologna 1994).
 Anche Ian Clark sottolinea che la globalizzazione introduce «mutamenti relativi sia all'intensità che alla dimensione spaziale delle relazioni internazionali». Accanto e in opposizione a una tendenza globalizzante c'è una tendenza alla frammentazione o localizzazione che ha la funzione di contenimento e di equilibrio, instabile sì ma tale da non rendere irreversibile il processo di globalizzazione (Globalizzazione e frammentazione: le relazioni internazionali nel XX secolo, il Mulino, Bologna 2001).
Anche Ian Clark sottolinea che la globalizzazione introduce «mutamenti relativi sia all'intensità che alla dimensione spaziale delle relazioni internazionali». Accanto e in opposizione a una tendenza globalizzante c'è una tendenza alla frammentazione o localizzazione che ha la funzione di contenimento e di equilibrio, instabile sì ma tale da non rendere irreversibile il processo di globalizzazione (Globalizzazione e frammentazione: le relazioni internazionali nel XX secolo, il Mulino, Bologna 2001).
Danilo Zolo, dopo un esame delle diverse interpretazioni, afferma che la globalizzazione «fa riferimento a un processo di estensione 'globale' delle relazioni sociali fra gli esseri umani, tali da coprire lo spazio territoriale e demografico dell'intero pianeta» (op. cit.).
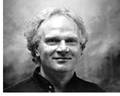 A questa interpretazione si può accostare quella di Ulrich Beck, il quale respinge una visione apocalittica dei processi di globalizzazione, anche se egli ha messo in evidenza che questa è una "società a rischio", dove viene meno la sicurezza sociale, con la conseguenza che le cosiddette "virtù borghesi" si trasformano in aggressività e desiderio di autodifesa. In tale situazione, un buon antidoto può essere l'abbandono di certi ideali, l'abbondanza, la carriera, il profitto, che sono diventati ossessivi e gli unici criteri di valutazione dell'uomo, e inventarci nuovi modelli di vita. (Il rischi della libertà. L'individuo nell'epoca della globalizzazione, il Mulino, Bologna 2001). Successivamente Beck ha ribadito che verso il processo di globalizzazione occorre avere un atteggiamento dialettico, nel senso di scorgere non solo gli aspetti negativi, ma anche le opportunità che offre quella che egli ha definito "seconda modernità", fondata su valori di uguaglianza, libertà e capacità d'informazione. (Che cos'è la globalizzazione: rischi e pericoli nella società planetaria , Carocci, Roma 1999).
A questa interpretazione si può accostare quella di Ulrich Beck, il quale respinge una visione apocalittica dei processi di globalizzazione, anche se egli ha messo in evidenza che questa è una "società a rischio", dove viene meno la sicurezza sociale, con la conseguenza che le cosiddette "virtù borghesi" si trasformano in aggressività e desiderio di autodifesa. In tale situazione, un buon antidoto può essere l'abbandono di certi ideali, l'abbondanza, la carriera, il profitto, che sono diventati ossessivi e gli unici criteri di valutazione dell'uomo, e inventarci nuovi modelli di vita. (Il rischi della libertà. L'individuo nell'epoca della globalizzazione, il Mulino, Bologna 2001). Successivamente Beck ha ribadito che verso il processo di globalizzazione occorre avere un atteggiamento dialettico, nel senso di scorgere non solo gli aspetti negativi, ma anche le opportunità che offre quella che egli ha definito "seconda modernità", fondata su valori di uguaglianza, libertà e capacità d'informazione. (Che cos'è la globalizzazione: rischi e pericoli nella società planetaria , Carocci, Roma 1999).
 Il sociologo Zygmunt Bauman ha dedicato parecchi lavori alla condizione umana nell'epoca della globalizzazione. Egli nega che nel processo di globalizzazione ci sia una progettualità predeterminata da parte di Stati o multinazionali, e traccia un quadro attendibile dei molti problemi esistenziali che l'uomo deve affrontare in questa nuova situazione. In particolare, egli mette in evidenza che la globalizzazione riguarda la vita quotidiana e il destino di milioni di uomini, pertanto la dimensione globale viene vissuta in termini locali e individuali, e su questi aspetti si sofferma lungamente. (Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Bari-Roma 2005 8). Ha accentuato la condizione di isolamento in cui vive l'uomo globalizzato in La solitudine del cittadino globale (Feltrinelli, Milano 200), mentre in La società dell'incertezza (il Mulino, Bologna 2001) ha espresso una valutazione complessiva più negativa della società globalizzata rispetto ai precedenti interventi. La società odierna è caratterizzata dall'incertezza; il mondo è percepito come malsicuro, privo di solidità e ciò provoca un permanente senso d'inquetudine. È una società che preferisce alla sostanza l'apparenza, ossia una vita che cerca dei surrogati: la salute diventa fitness, la libertà è identificata nello zapping, e così via.
Il sociologo Zygmunt Bauman ha dedicato parecchi lavori alla condizione umana nell'epoca della globalizzazione. Egli nega che nel processo di globalizzazione ci sia una progettualità predeterminata da parte di Stati o multinazionali, e traccia un quadro attendibile dei molti problemi esistenziali che l'uomo deve affrontare in questa nuova situazione. In particolare, egli mette in evidenza che la globalizzazione riguarda la vita quotidiana e il destino di milioni di uomini, pertanto la dimensione globale viene vissuta in termini locali e individuali, e su questi aspetti si sofferma lungamente. (Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Bari-Roma 2005 8). Ha accentuato la condizione di isolamento in cui vive l'uomo globalizzato in La solitudine del cittadino globale (Feltrinelli, Milano 200), mentre in La società dell'incertezza (il Mulino, Bologna 2001) ha espresso una valutazione complessiva più negativa della società globalizzata rispetto ai precedenti interventi. La società odierna è caratterizzata dall'incertezza; il mondo è percepito come malsicuro, privo di solidità e ciò provoca un permanente senso d'inquetudine. È una società che preferisce alla sostanza l'apparenza, ossia una vita che cerca dei surrogati: la salute diventa fitness, la libertà è identificata nello zapping, e così via.
L'inizio della globalizzazione
 Un altro dei problemi più dibattuti riguarda l'inizio della globalizzazione: è un fenomeno recente o si riscontra anche nel passato?
Un altro dei problemi più dibattuti riguarda l'inizio della globalizzazione: è un fenomeno recente o si riscontra anche nel passato?
Alcuni sostengono che il primo episodio di globalizzazione si è avuto con la scoperta dell'America, seguito da altri, come il capitalismo industriale dell'Ottocento; oggi saremmo di fronte a una nuova fase caratterizzata in larga misura dalla rivoluzione informatica.
Secondo Judith Wallerstein la globalizzazione è un processo di lunga data nella costruzione del "sistema mondo", contrassegnato da una progressiva espansione capitalistica avviata dalla scoperta dell'America. (Il sistema mondiale dell'economia moderna , il Mulino, Bologna 1982).
 Infine segnaliamo un libro del filosofo Peter Sloterdijk, L'ultima sfera. Breve storia filosofica della globalizzazione (Carocci, Roma 2002), in cui sostiene che la globalizzazione è il punto d'approdo non definitivo di un lungo processo storico. Essa è presente fin dall'inizio della filosofia greca, che ha considerato la physis, ossia la natura complessiva e unitaria, come totalità. È una concezione e un obiettivo che attraversa tutto il pensiero filosofico occidentale, ripercorso dallo studioso in modo penetrante ed efficace.
Infine segnaliamo un libro del filosofo Peter Sloterdijk, L'ultima sfera. Breve storia filosofica della globalizzazione (Carocci, Roma 2002), in cui sostiene che la globalizzazione è il punto d'approdo non definitivo di un lungo processo storico. Essa è presente fin dall'inizio della filosofia greca, che ha considerato la physis, ossia la natura complessiva e unitaria, come totalità. È una concezione e un obiettivo che attraversa tutto il pensiero filosofico occidentale, ripercorso dallo studioso in modo penetrante ed efficace.
