Presidi e direttori didattici in Italia
Fuori dalla leggenda nera
 In questa rapida rassegna della «leggenda nera» non compaiono i presidi italiani. Difficile pensare che non vi siano stati capi di istituti degni di entrare in una simile galleria di mostri. Forse non hanno trovato lo scrittore adatto; le loro vittime non avevano le doti di un Thomas Mann o, più modestamente, di George Orwell.
In questa rapida rassegna della «leggenda nera» non compaiono i presidi italiani. Difficile pensare che non vi siano stati capi di istituti degni di entrare in una simile galleria di mostri. Forse non hanno trovato lo scrittore adatto; le loro vittime non avevano le doti di un Thomas Mann o, più modestamente, di George Orwell.
La ragioni sono altrove.
La debolezza dello Stato e delle sue istituzioni, la lunga ostilità della famiglie e della Chiesa verso l'istruzione laica, la mancanza di un bagaglio di valori comuni, di una «religione civile» (come diceva Croce) che coltivasse nei cittadini il culto della tradizione e il senso di un destino collettivo, l'assenza di una dirigenza amministrativa autonoma dai politici e al contempo gelosa delle proprie prerogative e del proprio compito «al servizio della Nazione»; tutto questo, e altro ancora, ha contribuito a tenere - basso il profilo del capo di istituto, anche nel male.
Non esiste nessun preside italiano che abbia la monumentale e malvagia grandezza di un Rex. Basta confrontare l' ingresso in aula di Rex:
E allora vide subito che a entrare in classe era il rex. Indossava un leggero abito grigio-perla, la giacca era sbottonata e, sotto, una camicia bianca gli si gonfiava sulla pancia; chiaro e corpulento, si stagliò per un attimo sul grigio del corridoio, poi la porta si chiuse dietro di lui: qualcuno che lo aveva accompagnato, ma che rimaneva invisibile, doveva averla aperta e richiusa.
(Andersch, 1980, p. 11)
... con quello di un poveretto di preside ricordato da Gadda:
La maniglia all'uscio dava segno di agitarsi; l'uscio si dischiudeva: una bianca lingua di spuma, tra due scoglie, e il barbone bianco del preside si insinuava nello spiraglio, fra uscio e stipite, e tuttavia con una certa predisposizione al reflusso. Il suo vocione tuonava, si studiava di riuscir temibile: «Mi pare d'aver udito del baccano!» «No, signor preside! Qui no, glielo possiamo garantire!» dicevano, ilari e ossequienti.
(Gadda, 1963, p. 276)
Il fascismo fece un patetico tentativo di rivitalizzare questa professione, dandole una aspetto più marziale, ma cadde nel ridicolo, che è rimasta la dimensione più familiare del preside italiano quando aspira all'autorità degli esempi europei, soprattutto tedeschi. Ha un bel da fare Augusto Monti a convincere il suo Preside Pagàn a usare la sua autorità contro i ragazzi in sciopero (siamo nel 1922):
Vado diritto in presidenza. «Permesso?», «Avanti». Senza tanti preamboli, faccia piuttosto scura e piglio piuttosto deciso, prego il buon Pagàn che mi racconti «come la xe andada». Mi risponde quel che avevo già indovinato da me: quelli dell'istituto con un po' di schiuma extrascolastica in cima, urli, spintoni, bidelli e custodi respinti, porte sforzate, spavento dei piccoli e delle signorine... «a evitare il peggio...» braccia allargate pietosamente rassegnate «...forza maggiore».
- E adesso, signor Preside? - Adesso cosa?
- Eh, le circolari, le disposizioni così così e così, «accertare e punire».
- Eh, lei è giovane... del resto è la prima volta qui da noi, e poi - sapeva come la pensavo, e lui in fondo la pensava come me.
- «motivi ideali» - e sorrideva il buon vecchio papà come per disarmarmi.
(Monti, 1965, p. 367)
Quel poco che rimaneva lo distruggerà il '68, ignaro di uccidere un fantasma ideologico, di cui questa predichetta di Walter Veltroni non fa che confermare la dimensione comica:
 Nell'antinomia studente sfrontato-preside si possono riconoscere i segni di un lento processo di autonoma liberazione dal fardello dell'autorità, di acquisizione della identità di «giovane», di riaffermazione di un «potere» dato dalla coscienza di costituirsi di una generazione, fondamentalmente omogenea nelle domande, nei sentimenti, nei gusti, nelle aspirazioni.
Nell'antinomia studente sfrontato-preside si possono riconoscere i segni di un lento processo di autonoma liberazione dal fardello dell'autorità, di acquisizione della identità di «giovane», di riaffermazione di un «potere» dato dalla coscienza di costituirsi di una generazione, fondamentalmente omogenea nelle domande, nei sentimenti, nei gusti, nelle aspirazioni.
(Veltroni, 1991, p. 6)
Il preside che ha suscitato tanto impegno critico va almeno ricordato come l'unico esempio della crudeltà di una professione scomparsa. Non se ne conosce il nome, ma l'opera è rimasta:
Scese un silenzio terrificante; il professore se ne andò, senza una parola. L'attesa apparve lunghissima e fu interrotta solo dalla perentoria irruzione del preside. Gli alunni furono fatti restare in piedi vicini ai loro banchi. Il preside si avvicinò al colpevole e gli sibilò in faccia: «Lei, chi crede di essere?». Il ragazzo lo guardò, e con un impeto di orgoglio non privo di paura, rispose con sicurezza: «Il mio nome è Bond. James Bond». Fu sospeso per una settimana, per delitto di lesa maestà.
(Veltroni, 1991, p. 6)
E questo anonimo preside va ricordato insieme all'altro, altrettanto severamente comico, che apre il bel racconto di Erri De Luca:
Nell'apnea totale dei presenti dichiarò che esigeva i colpevoli, altrimenti avrebbe sospeso l'intera classe a scadenza indeterminata, compresi gli assenti di quel giorno.
(De Luca, 1994, p. 5)
Anche per i presidi resta vero quanto dice Meneghello per gli insegnanti. «In generale si può dire che a S. [un compagno di scuola, n. d. a. ] venne a mancare quasi del tutto l'esperienza dell'odio per gli insegnanti, senza della quale uno non può essere un uomo completo.»
Le stagioni dei capi d'istituto italiani
 Il dibattito sui capi di istituto, a cominciare dai direttori didattici, fu vivace fin dai primi anni dell'Unità e trovò ampia eco nelle aule parlamentari. De Sanctis per primo si rese conto dell'importanza di questo ruolo se, il 23 gennaio 1874, fece un quasi accorato appello al Parlamento per l'istituzione della direzione delle scuole:
Il dibattito sui capi di istituto, a cominciare dai direttori didattici, fu vivace fin dai primi anni dell'Unità e trovò ampia eco nelle aule parlamentari. De Sanctis per primo si rese conto dell'importanza di questo ruolo se, il 23 gennaio 1874, fece un quasi accorato appello al Parlamento per l'istituzione della direzione delle scuole:
De Sanctis
"Io non so concepire una scuola, cioè a dire un complesso di maestri e di materie, senza una mente unica la quale coordini quelle materie, armonizzi quei maestri e li faccia tutti camminare verso uno scopo unico; altrimenti voi avrete chi diligente e chi distratto; chi tira in qua e chi in là; avrete l'anarchia. Per me la garanzia di una buona scuola è un buon direttore... Se questi direttori sono uomini competenti, che abbiano fatto le loro prove, voi dovete dare a essi tutta l'autorità possibile, la facoltà di decidere tutti gli affari locali. È sempre un progresso quando gli affari fioriscano nelle stesse mani dove cominciano, senza bisogno di tanti controlli e controlli di controlli."
(De Sanctis, 1874, p. 187)
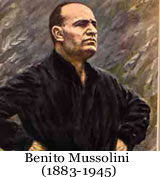 L'appello fu raccolto, ma la retorica e l'oratoria fascista esaltò, fino a ridicolizzarlo, il ruolo autoritario del preside, al quale si richiedeva «quella socratica penetrazione che è la qualità dei duci» insieme all'invito a essere «vigili scolte che rispettano, come cosa sacra, con militare devozione, assoluta e incondizionata, la consegna dovuta».
L'appello fu raccolto, ma la retorica e l'oratoria fascista esaltò, fino a ridicolizzarlo, il ruolo autoritario del preside, al quale si richiedeva «quella socratica penetrazione che è la qualità dei duci» insieme all'invito a essere «vigili scolte che rispettano, come cosa sacra, con militare devozione, assoluta e incondizionata, la consegna dovuta».
Passata la sbornia, si rinfocolò le tesi del preside elettivo:
 "Ci sono anche proposte di carattere individuale: che direttori e ispettori vengano eletti democraticamente dai maestri: che abbiano non meno di dieci anni di servizio e 30 anni di età i primi, e non meno di 15 (fra insegnamento e direzione) e rispettivamente 35, i secondi; che tanto gli uni quanto gli altri possano essere revocati, se indegni, da coloro stessi che li hanno eletti. (Commissione nazionale d'inchiesta per la riforma della scuola, 1950, p. 58)
"Ci sono anche proposte di carattere individuale: che direttori e ispettori vengano eletti democraticamente dai maestri: che abbiano non meno di dieci anni di servizio e 30 anni di età i primi, e non meno di 15 (fra insegnamento e direzione) e rispettivamente 35, i secondi; che tanto gli uni quanto gli altri possano essere revocati, se indegni, da coloro stessi che li hanno eletti. (Commissione nazionale d'inchiesta per la riforma della scuola, 1950, p. 58)
Eppure l'Inchiesta sulla scuola del 1950 testimonia che la maggioranza dei presidi, nonostante il periodo di vuota esaltazione, aveva conservato le competenze e un po' del prestigio dell'epoca liberale:
[...] in generale molto buona [l'efficienza delle funzioni direttive, n. d. a. ]. Alcuni presidi e direttori veramente eccellono e la maggioranza di istituti e scuole risulta affidata a uomini coscienti, competenti e esperti della vita scolastica, dotati di amore per la scuola e di spirito di abnegazione. (Commissione nazionale d'inchiesta per la riforma della scuola, 1950, p. 275)
La classe politica della «prima Repubblica», a diversità dei governi dei maggiori Paesi europei, in nome dell'antifascismo, non ha preservato questa preziosa risorsa della tradizione, lasciandosi andare a una deriva demagogica e «antiautoritaria» che ha fatto danni difficilmente riparabili.
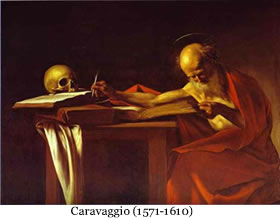 Il preside, «espulso» dalla dirigenza pubblica nel 1972 con la legge 748, venne ridotto a un semplice coordinatore senza autonomia né responsabilità educative, nonostante i tentativi degli studiosi più avvertiti di innovare e ammodernare il suo ruolo in un ambiente reso incandescente dalla contestazione. Così, la banalizzazione del ruolo ha ostacolato non solo la ricerca scientifica sui vari aspetti della professione, ma anche gli strumenti di formazione, di selezione e di aggiornamento.
Il preside, «espulso» dalla dirigenza pubblica nel 1972 con la legge 748, venne ridotto a un semplice coordinatore senza autonomia né responsabilità educative, nonostante i tentativi degli studiosi più avvertiti di innovare e ammodernare il suo ruolo in un ambiente reso incandescente dalla contestazione. Così, la banalizzazione del ruolo ha ostacolato non solo la ricerca scientifica sui vari aspetti della professione, ma anche gli strumenti di formazione, di selezione e di aggiornamento.
Per molto tempo, fino all'inizio degli anni Ottanta, il preside venne cooptato senza concorso dalla burocrazia amministrativa con criteri eminentemente politici da «manuale Cencelli».
Solo i concorsi banditi nel 1979 hanno creato le premesse per la ricostruzione della funzione direzionale, come testimoniano le indagini sociologiche, dove si riconosce il notevole contributo dato dai presidi all'innovazione organizzativa e didattica, e la radicale modificazione dell'immagine stereotipata coltivata da politici e sindacalisti:
[...] emerge una valutazione non negativa nei confronti di questa figura [del preside, n.d.a.], rispetto alla quale appaiono superate in gran parte le pregiudiziali degli anni Settanta (anzi il 54% degli intervistati ritiene il preside il principale soggetto di stimolo e promozione dell'innovazione).
(Censis, 1989, p. 141)
Occorre arrivare all'articolo 21 della legge n.59/97 e al successivo Decreto legislativo 165/2001 per tentare di ricostruire la funzione dirigenziale
 Ma mentre in tutto il mondo si accentua la funzione di "leadership educativa", in Italia l'operazione sulla dirigenza è avvenuta emulando il modello amministrativo-burocratico. Questo ha approfondito il distacco fra insegnanti e dirigenti, oberati da compiti gestionali e contabili. La dirigenza scolastica, già "ferita" da dequalificanti sanatorie, rischia di diventare una funzione esterna all'educazione.
Ma mentre in tutto il mondo si accentua la funzione di "leadership educativa", in Italia l'operazione sulla dirigenza è avvenuta emulando il modello amministrativo-burocratico. Questo ha approfondito il distacco fra insegnanti e dirigenti, oberati da compiti gestionali e contabili. La dirigenza scolastica, già "ferita" da dequalificanti sanatorie, rischia di diventare una funzione esterna all'educazione.
Non deve quindi stupire la diversità dei toni e dei contenuti delle testimonianze di presidi di altri paesi, come la Francia, che si inseriscono in un sistema scolastico, per quanto in difficoltà, certamente caratterizzato da una solida tradizione, sostenuto da un'opinione pubblica competente e da un'amministrazione fiera della sua efficienza: valori ancora irreperibili nel nostro Paese. I presidi italiani che hanno fatto i conti col proprio lavoro ne tracciano un bilancio fallimentare. Hanno scritto i loro ricordi delusi e quasi sfiniti da una professione poco gratificante e misconosciuta. Tutti sembrano suggellare nella pagina scritta la rinuncia alla carriera, quasi per metterci una pietra sopra.
Il Preside Pacchiano conclude il suo fortunato libro quasi con disperazione:
Questa è oggi la scuola italiana: isolata, esclusa, abbandonata ai suoi guai. Solo una società profondamente diversa e più giusta - ma quando mai ci sarà? - che riconduca studenti e insegnanti a essere protagonisti, pari grado, della vita educativa, la potrà trasformare. Ma, come si ritiene da sempre che tocchi alla scuola formare un mondo migliore, ci si trova di fronte a un'irrimediabile situazione di stallo: il gatto che si morde la coda. Nulla cambia.
(Pacchiano, 1993, p. 221)
Una conclusione che prelude all'abbandono definitivo:
A marzo (mancavano pochi giorni alla scadenza della domanda) ho deciso: basta scuola, basta orari, insegnanti, circolari del ministero. Basta sentir proclamare a gran voce che la scuola funziona e che funzionerà sempre meglio, e che i suoi detrattori sono degli incoscienti. Stop alla burletta del preside manager, senza management e senza quattrini. Finalmente sono arrivati i giorni dell'ira impiegatizia: basta di basta di tutto e al diavolo tutto. Ho pensato «Ho quasi cinquantadue anni; ne ho impiegato quarantasei per liberarmi della scuola. Complimenti un bel record. Farò altro, non farò nulla, non so; ma via di qui per favore.
(Pacchiano, 1996, p. 11)
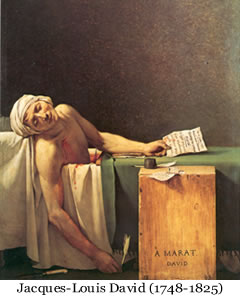 Prima di lui anche la preside Fiorentini scriveva l'epigrafe sulla tomba della sua esperienza, appassionatamente vissuta, ma ancora alla ricerca di un senso:
Prima di lui anche la preside Fiorentini scriveva l'epigrafe sulla tomba della sua esperienza, appassionatamente vissuta, ma ancora alla ricerca di un senso:
La scuola, che pareva il luogo adatto per condividere e nutrire questa passione, con le sue assurdità - quanto latino, quanta religione, quanta informatica sembrano, ora, i suoi unici problemi - si è rivelata, giorno dopo giorno, talmente inadeguata da sospingermi sempre più ai margini. Sono passati più di trent'anni. Non so se ci resterò ancora, a misurare la dose giusta di piccoli piaceri per docenti e studenti. Forse non ha più senso.
(Fiorentini, 1989, p. 254)
Tutto sembra essere cominciato nel '68, come testimonia il preside Georgiacodis del Liceo «Einstein» di Milano.
E, una volta tanto, è un preside a fare i conti con l'ignavia dei politici, l'opportunismo dei genitori borghesi e la fatuità retorica e violenta degli studenti. La sua denuncia appare oggi, in un'epoca di bilanci in rosso e di debiti non solo finanziari, straordinariamente attuale; soprattutto di fronte allo stanco ripetersi dei riti della contestazione studentesca (con il seguito di occupazioni, slogan, manifestazioni, ecc.), che ha tutto il sapore di una clonazione, dietro la quale si nasconde una classe politica con la coda di paglia, accanto a una borghesia di reduci che stenta a fare i conti con l'esperienza passata.
Georgiacodis non disconosce il retaggio «rivoluzionario» del '68, ma ha lucida coscienza dei suoi danni:
Infatti, nel tumultuoso intermezzo tra scuola ignava e scuola utopica, tra il '68 e 1'83, si registra in Italia una rivoluzione del costume, in parte tradotta in leggi, rivolgimento che, pur fuori della tematica politica dei sessantottini, si può ricondurre al loro fatidico anno. Emancipazione della donna, regolamentazione dell'aborto, pillola, divorzio, nuovo diritto di famiglia, voto ai diciottenni, tolleranza della diversità, ecc. Mutazioni che nascono parallele al moto ribellistico anti-Scuola, se ne alimentarono e lo legittimano, tutto il resto essendosi invece risolto in perdita secca per la cultura e i giovani. Che, indifesi perché intellettuali dimezzati, continuano a essere strumentalizzati: ieri da chi li voleva in armi contro lo stato, oggi, con altri mezzi, da tutti: rotocalchi che ne affidano i blandimenti a sdolcinati pedagoghi non migliori di quelli che sono stati ieri «i cattivi maestri»; da partiti che nei vari festival, tra amicizia e pace, s'ingegnano ad arpionarli; dal management mercantile che, con l'occhio al fatturato, ne verificala fatuità, dall'hippy all'unisex arretrandoli alle leziosaggini degli anni Venti: da gente senza scrupoli, che ne sfrutta le frustrazioni avviandoli all'autodistruzione.
(Georgiacodis, 1984, p. 213)
E, dopo quasi quindici anni, questa diagnosi viene significativamente a coincidere con quella di un giovanissimo che ha il coraggio di aprire gli occhi impietosamente sulla condizione studentesca.
A ascoltarli [gli studenti, n.d.a.], a raccogliere le loro impressioni, a analizzare i loro slogan, una schiera di giornalisti, sociologi, opinionisti.
Tutti estasiati di fronte al «risveglio» dei giovani, al loro ritorno sulla scena pubblica.
Peccato che a tutta questa gente, i ragazzi non abbiano nulla da dire. In piazza infatti, tendono a portarsi dietro tutto l'armamentario del '68 (il che spiega il brivido di nostalgia che percorre ogni volta l'etere). Disinformati, strumentalizzati, confusi e divisi si ostinano a sprecare l'impressionante copertura che i media riservano loro scandendo inutili slogan contro la «privatizzazione» e il ministro di turno, occupando istituti e organizzando gruppi di studio sulla «condizione della donna oggi», sulle «problematiche del capitalismo maturo», sul «nuovo cinema italiano». Fumosi, ideologizzati, continuano a lasciarsi sfuggire l'occasione di esprimere un disagio indubbiamente giustificato in termini che abbiano un minimo di credibilità. (Empoli, 1996, p. 71)